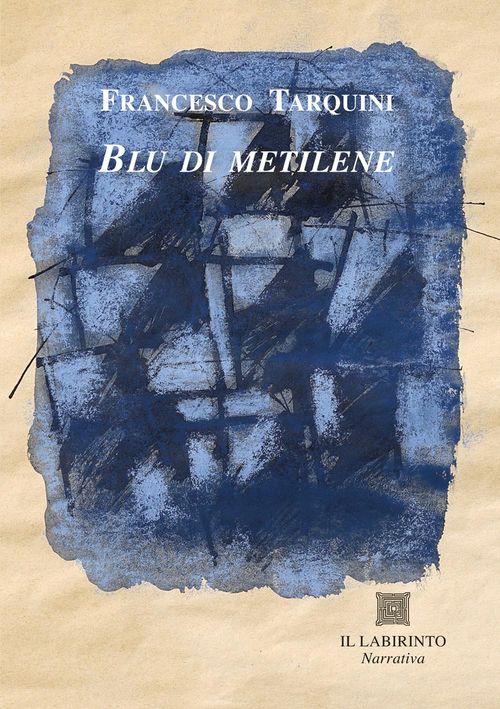 Il fantasma ostensivo di una città, il ritorno che non è mai possibile perché ogni cosa non è mai la stessa, le presenze che però fanno della città dalle dodici torri un luogo-mito: sono alcuni degli elementi portanti di Blu di metilene, racconto di Francesco Tarquini, esperto di letterature ispano-americane e non solo. Il fantasma ostensivo di una città, il ritorno che non è mai possibile perché ogni cosa non è mai la stessa, le presenze che però fanno della città dalle dodici torri un luogo-mito: sono alcuni degli elementi portanti di Blu di metilene, racconto di Francesco Tarquini, esperto di letterature ispano-americane e non solo.
La Asilah narrata da Tarquini è una direzione dello spirito, ma nel contempo è la città reale con i suoi abitanti anonimi, e questo anonimato è la forza ctonia che innerva la storia, perché i caffè, le strade diurne e notturne, i raccontatori e le affabulatrici misteriose, nuove e diverse Sherazade, gli artisti che non vendono le loro opere sono protagonisti che vivono nel sottofondo anche quando non vengono nominati. Come accade in qualsiasi luogo. Perché il luogo è portatore, con la sua rete di relazioni e nascondimenti, assenze e presunte follie, di significati che vanno oltre la ratio d’occidente, ed è anche per questo che la storia avviene qui.
Una storia? può darsi, a patto che essa non venga assimilata ad una narrazione allineata con i princìpi non tanto della retorica commerciale ed editoriale quanto di un discorso preordinato e guidato da una fabula.
Talvolta l’Ermes nominato in Blu di metilene porta il lettore verso il senso del riconoscimento oltre i limiti dell’ovest e del nord, in linea con il Bowles non amabilmente citato qui, e che invece con il suo romanzo più celebre ha narrato anche la possibilità, che non è per forza esotismo, di perdersi altrove. Anche perché un Lawrence o un Rimbaud cercarono radici altre, o forse paradisi perduti, che non è cattiva letteratura, ma disperata ricerca di qualcosa che è già stato nostro, “ritrovare la città senza averla mai perduta” come qui evocato. E non lontano dall’Ermes di Rilke che deve assistere, perché la Ananke è superiore al volere degli dèi, all’inutilità dello sforzo di riportare nel qui e nell’ora ciò che è già stato. Solo chi riconosce il divino, sia pure quello immanente, nel cammino attuale, nella capacità di cogliere l’epifania dell’incontro, del significato profondo dello spazio e del suo colore dominante, può narrare, come nel caso di Blu di metilene, il contatto con lo spirito del luogo.
Certo è che se da una parte Tarquini sfugge alle sirene dell’esotico, dall’altra riesce anche nella difficile realizzazione di pagine non assimilabili a generi, proprio perché libere da esigenze di captatio benevolentiae in cui certamente esistono possibilità di paragoni: esse sono inserite nell’infinito rischio della vicinanza dei temi umanamente narrabili, in questo caso quello del cimitero, che attraversa la letteratura con Gray, Valery, Masters, solo per fare pochi nomi, e che affronta la storia delle persecuzioni e delle conquiste, delle difese e delle mescidazioni e che riporta il grande motivo della proclamazione – e della scrittura – del nome come sfida contro l’oblio e il non senso.
Una sfida che trova una delle sue tappe nel Caffè dei pescatori di Asilah, come scrive Tarquini “una sorta di iniziazione” in cui l’occidente è ammesso all’incontro con l’essenza del luogo, apparentemente senza nome ma per questo immagine collettiva di una identità sotterranea e ancora più reale.
Il cammino di erranza è quello del riconoscimento delle diversità e nello stesso tempo della fratellanza rintracciata grazie proprio a quelle diversità, che fanno il vero dialogo non nello sforzo ideologico e nell’utopia politica, ma nell’accettazione dell’altro.
Asilah come nuova città, e non è un caso che i luoghi a lei vicini abbiano ospitato narratori d’occidente che hanno scelto di rimanervi, come anche alcuni protagonisti della musica contemporanea, che hanno tracciato i sentieri per nuovi e antichi orizzonti.
Francesco Tarquini, Blu di metilene, Il Labirinto, 2024, 110 pagine, 15 euro.
|
Da
BLU DI METILENE
di Francesco Traquini
“C’era, una volta, quella città sul mare?”. Quella piccola città la cui fondazione si perde in un remotissimo passato, e non lontano dalla quale tre re caddero in battaglia? Qualcuno dice che al giorno d’oggi non si può più cominciare una storia con “c’era una volta”, che è il modo in cui cominciano le favole. In quale altro modo narrare di un ritorno a un luogo al quale per tanti anni siamo tornati, ogni volta chiedendoci se davvero era esistito e se esisteva ancora? Ogni volta chiedendoci se davvero ne eravamo mai ripartiti?
Fluttuante, insicuro, è spesso il legame col tempo più di quanto insinui la memoria; volti, odori, voci, frammenti staccati dal momento in cui occorsero, mescolati a volte con altri frammenti, contaminati da somiglianze ingannevoli e nel contempo pienamente compiuti nella loro pur transitoria forma. Una catena di anacronismi che fa della memoria una autonoma dimensione del tempo, arbitrariamente variabile.
Esista dunque o no, anche oggi la città ci appare all’improvviso; oltre le saline, annunciata dal ponte sul fiume Tahadartz là dove le acque verdi cominciano a mescolarsi alle onde che l’Atlantico gli spinge nel letto mentre più in là le infrange su una spiaggia lunghissima e deserta.
Eccola, con le sue dodici torri e le sue cinque porte, fra il mare e le alture che annunciano la linea montagnosa del Rif. Azailah, Arzila, Arcilah, Arzilla, Assilah. Asilah. Assediata, conquistata, devastata più volte, più volte ricostruita. Arricchita della pingue ricchezza di un grande porto commerciale, e nel corso del tempo mestamente decaduta. In epoca lontanissima fondata da un pugno di marinai fenici, rifugio di naufraghi o piccolo scalo; lungamente dominata da Roma, preda di Goti, di Vandali, di Normanni; dagli Arabi ripetuta- mente perduta e riconquistata; eletta dai Portoghesi a prima tappa sulla via dell’oro africano e cinta di mura come una fortezza; a lungo nido di pirati barbareschi e più volte bombardata; per cinque lunghi decenni del secolo trascorso sottoposta al protettorato spagnolo, che lasciò dietro di sé una chiesa, commerci, alcune famiglie che accanto a musulmani ed ebrei avevano là messo radici, e sotto un fitto di eucalipti, un cimitero.
È alla stessa città che stiamo tornando, affacciata sull’Oceano, rivolta al tramonto?
|
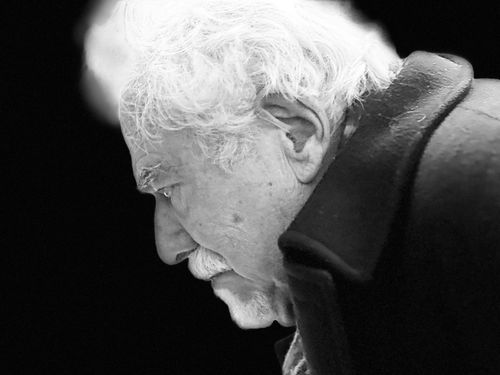 Francesco Tarquini Francesco Tarquini
È nato nel 1940 a Roma, dove risiede. Negli anni ’70 ha iniziato a occuparsi di letteratura ispanoamericana, partecipando in qualità di cultore della materia alla conduzione di seminari presso l’Università di Roma, mentre suoi scritti critici sono apparsi su riviste tra le quali Letterature d’America e Lingua e Stile. Dal 1980 al 1982 ha collaborato al quotidiano Il Manifesto con interventi di critica letteraria. Ha tradotto per Feltrinelli nel 1982 il romanzo Dejemos hablar al viento di Juan Carlos Onetti.
I suoi interessi sono rivolti prevalentemente alla poesia argentina, campo in cui opera con traduzioni e scritti critici. Per la casa editrice Fili d’Aquilone ha curato e tradotto Molestando a los demonios di Daniel Samoilovich, 2012; Contratiempo di Edgardo Dobry, 2015; Las Encantadas dello stesso Samoilovich, 2019 (sul quale un ampio saggio, nato dalla sua prefazione al libro, è stato pubblicato nel 2020 su Letterature d’America) e ¡Párense derecho! di Eduardo Ainbinder, 2022. Ha tradotto inoltre sillogi poetiche di autori fra i quali Juan José Saer, Mirta Rosenberg, Noni Benegas, Marta Miranda, Martín Andrade.
Da alcuni anni frequenta in modo assiduo la poesia italiana contemporanea con recensioni e scritture critiche. Suoi testi sono presenti sulle riviste Fili d’aquilone (alla quale collabora da oltre un decennio), Nuovi Argomenti-Officina Poesia, Poeti e Poesia, Rassegna Iberistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Metaphorica, Treccani Magazine. Ha pubblicato con l'editore Manni un libro di narrativa dal titolo Figure di spago, e con le Edizioni Il Labirinto Blu di Metilene nel 2024.
testimarco14@gmail.com
|