Tra una poesia e l’altra si distende
la prosa dei giorni...
Parlavamo per telefono dell’Adriano VII di Frederick Rolfe, io e Gianfranco Palmery, alcuni giorni prima che ci lasciasse. Gli raccontavo come avessi ricalcato, senza rendermene conto, in uno scritto recente, il memorabile ìncipit di quel libro. Fu allora che Gianfranco confessò di sentire molte pagine di esso, e il capitolo ventiduesimo (citato nelle Divagazioni sulla diversità) in modo particolare, affini alla sua condizione. La circostanza mi è tornata in mente quando ho iniziato a pensare a questo ricordo. Ed è come in quelle pagine che ho voluto scriverlo, ma con parole che somigliano a quelle di Gianfranco.
* * *
Aveva sempre descritto la sua casa come un reclusorio, un carcere dal quale cercare l’evasione; nel migliore dei casi un nascondiglio: il solitario asilo dove una musa, amante del silenzio e dell’ombra, potesse visitarlo a suo piacimento. Ma fu l’esperienza della malattia – che gli ultimissimi anni gli avevano riservato – ad allontanarlo in modo definitivo da un mondo nel quale già si sentiva straniero e a trasformarlo, da volontario recluso nella sua casa-cella, in un braccato dalla Morte.
Serra, serra le fila, rinsalda
i fili di questa sbrindellata
trama – arma la rocca, sbarra
tutti gli accessi: rinserrati, ritirati, oh
rientra in te! resisti alla ribalda
schiera, e veglia, vigila: né il furore
né il sonno per te era la via
divina – non l’angelo hai rinchiuso, chiusa
la porta, in casa con te, ma un insonne
dèmone che nelle tenebre d’insidie
e d’inganni ha seminato le tue ore.
Chi era, com’era quel dèmone insonne? Individuale: il Rancore, o il cattivo monaco di se stesso; o plurale: le Furie, le nere orchesse che orchestravano la danza; che da erinni potevano trasformarsi in eumenidi, trasfigurarsi in numi tutelari: Rolfe, Poe, Malcolm Lowry.
Le tende alla finestra venivano tirate per proteggersi dalle tenebre perché il fuori che premeva ai vetri non trasparisse, non entrasse. I vetri, rivestiti dall’argento della notte, si trasformavano in specchi gelidi e oscuri: in essi sprofondava la stanza illuminata. Nella quiete di quella camera alta, al quarto piano, egli aveva la sensazione di navigare sul mondo sottostante; in essa trascorreva le lunghe ore notturne a lavorare: a leggere o a scrivere. Ma per quanto, sbarrando porte e finestre, spegnendo radio e televisore, ignorando i giornali, avrebbe potuto chiudere fuori l’inferno? Il televisore, poi, ogni tanto lo accendeva per rivedere qualche vecchio film: con quell’attore che gli piaceva, Mickey Rourke, impegnato a combattere la mafia cinese, o nella parte di un disperato, imbolsito vecchio wrestler; con la misteriosa Kim Novak di Vertigo, ovvero La donna che visse due volte: l’Hitchcock che preferiva; o il Johnny Guitar di Nick Ray.
Quella stanza, quante volte l’aveva descritta! E, magistralmente, con la preveggenza che i poeti esercitano spesso senza saperlo, in essa la passività delle sue ore di malato, il modo inutile e inerte di trascorrere il tempo, da quando la poesia sembrava averla lasciata deserta. Dal letto tumultuante di lenzuola e coperte, abbandonato sui cuscini, si guardava intorno e il suo sguardo scivolava sui piani impolverati, inciampava negli spigoli, negli angoli... Non vedeva che cartelle su cartelle posate a ingiallire su mensole e sgabelli; fra di esse e libri e carte impolverate, i simboli e le insegne del tempo e della sua vanità: orologi, monete. E schiere di libri messi in fila sugli scaffali, o impilati uno sull’altro: sui loro dorsi, “pazienti e immacolati messi insieme come pagine di diario”, stando a letto aveva preso l’abitudine di studiare le combinazioni che ombre e luci vi creavano col trascorrere dei minuti, delle lunghe ore d’inedia. Che fine avrebbero fatto quei libri? Sarebbero stati ammucchiati e inscatolati da mani estranee che li avrebbero macchiati di grasso e polvere? Sugli stessi scaffali, altre reliquie che il tempo aveva storditamente accumulato, tesori svalutati: rose, tante rose rinsecchite, un crocefisso, un calice, un immancabile teschio; e infine gli strumenti del mestiere,
strumenti di fervore e di ozio operoso:
una penna, una lente che spegne il suo fuoco
nella polvere, forbici e dovunque
matite – cespugli di gialle aste
appuntite...
Aveva forse esagerato a convocare i propri dèmoni, a volerli rinchiudere in casa con sé; ad assumerli, anzi ad assimilarli come tormenti. Ed ora quella scelta o forse necessità era diventata destino. Un tempo evitava le strade avvelenate di città perché la sua aria mortale doveva stare nascosta in casa. Adesso cosa restava?
Legato al palo, appeso, un solo appiglio
per l’ossesso che spenzola al suo male
– la buia gloria della depressione.
Perdeva forse il suo tempo, rimproverandosi per questo, ma continuando a perderlo. O era piuttosto il suo tempo che perdeva lui, lasciandoselo dietro, ritardatario sempre in attesa (“di che? di Dio?”), lungo giorni l’uno uguale all’altro come copie conformi. “Largo al mio tempo perduto!”, poteva esclamare andando da una stanza all’altra, sostando in cucina, fra pentole e padelle, scaldandosi il latte, tagliando il pane, imburrandolo e, presa la gatta sulle gambe, facendo colazione. La sua gatta, Marzia, marzolina, suo conforto:
Tu furietta di marte, armata, alata
mercuria che attraversi la casa
e la incanti...
L’amava quando si tendeva e scattava su prede del tutto immaginarie, quando giocava o si ritraeva svogliata, quando correva agli odori che venivano dalla cucina. Ne amava la buia luce balenante, le cacce, i salti, perfino i graffi e i morsi... Era capace di fare le fusa e miagolare come lei, lasciava che gli dormisse sulla pancia, forse le parlava anche con la lingua dei gatti, nel modo più divertente:
bella belva nell’ombra
dietro ogni porta pronta –
il naso cacciatore
e le orecchie guerriere:
la tua caccia è d’amore
stanarmi è il tuo mestiere.
Quando Marzia andava via, attratta da nuovi giochi, non se ne dispiaceva: la “furietta” aveva altri bisogni, e sogni dai quali era escluso. Ricadeva inerte, “sempre più arreso all’inedia, al tedio, al sonno”; forse avrebbe voluto scrivere, come Poe, “sto morendo, eppure non sono pigro – né ho commesso alcun reato contro la società da meritare un così duro destino”. Sperava nel soccorso di uno squillo, ma anche di questo si rimproverava:
Non stare lì a sperare che il telefono
squilli, che qualcuno desideri
sentire la tua voce – se sentirti
un tempo morto al mondo
ti piaceva, ora è il mondo
che ti considera morto...
Il passare del tempo l’esauriva, e gli portava un continuo desiderio di sonno. Era spesso intorpidito, l’intelletto nebuloso e incerto. Allora chiudeva gli occhi e si abbandonava. Non era certo accidia nel senso confessionale della parola, la sua. Era solo letargico, sfinito dalla passività, smagrito e consumato, col solo desiderio di fuggire e riposare, riposare...
Stava abbandonando il mondo. Anni prima, già aveva immaginato d’avviarsi coi suoi gatti in muta carovana, morto ai suoi richiami, spogliandosi d’ogni appetito, come i serpenti della pelle, ma stavolta... Eppure, nel complesso, non aveva più paura di morire.
Ora che sei davvero vuoto e spento
non provi più né pena né spavento!
Era un conforto, pensarlo. Socrate credeva che la morte fosse il nostro più grande possedimento sulla terra; Seneca, che fosse la migliore invenzione della vita; e Montaigne, facendogli eco, l’opera della vita: quest’ultimo pensiero, che aveva usato come epigrafe e titolo del suo secondo libro, era il più convincente. Invece a san Paolo, quando asseriva che morire è vincere, non credeva. Quale poeta non vorrebbe vincere il tempo con la forza della sua poesia? “Fare poesia è imparare a morire”, aveva scritto. Prima d’essere un bel verso, era la lucida espressione di una verità: i poeti lo sanno. Eppure temeva di addormentarsi, adesso; temeva quell’appuntamento notturno con la morte, perciò provava a restare sveglio, disteso sul dorso, sollevato, col cuscino dietro la schiena, le braccia lungo i fianchi, immobile, ma col cervello attivo, attivo e che contava i battiti, che meditava sul futuro, pensava, faceva progetti... Tutto pur di respingere l’assedio. Ma, infine, il sonno tanto temuto l’aveva vinta e la mente vi si abbandonava, sprofondava,
mentre una turba
di pensieri uncinati mezzi ciechi, avidi
predatori l’arremba, la saccheggia, o con lenta
quotidiana rapina [...] a poco
a poco la spoglia dei suoi tesori.
Di continuo, a ogni ora del giorno e della notte sentiva rintronargli la testa un fragore che era il battito del cuore. Allora sopravveniva una reazione: si ridestava, era preso dalla necessità di agire, di reagire: voleva continuare a vivere e a scrivere. Capiva che non doveva più lasciarsi andare, che un solo istante di resa poteva essere l’ultimo. Smesse le disperate angoscie di un tempo aveva ancora
la voglia, la volontà di dare forma
a una materia sempre più inerte
sempre più esigua, più esile, quasi
inesistente...
come il suo corpo che smagriva e si assottigliava... (Che si sarebbe sfatto tra le lenzuola, sciolto in grumi e umori indefinibili di sangue e fiele, distillate quintessenze già immaginate, con macabro umor nero, in una lontana poesia?). Come la vita che svaniva...
O vita senza vita
che somigli a una morte senza morte.
La vita, terribilmente concentrata su se stessa e solitaria, essendole negate le abituali occasioni d’agire, le comuni attività legate alla lettura, al lavoro e, soprattutto, alla scrittura, perché tutto ora costava fatiche insopportabili; la sua vita aveva sviluppato una straziante complessità. La ginnastica mentale con la quale si allenava, l’aveva portato a un tale grado di introspezione da rendere quasi sovrumana la sua facile, flessibile abilità di ragionamento. Perché la mente era vigile, guizzante come Marzia sulla preda adocchiata. Ma quando alla debolezza e alla sofferenza del corpo si aggiungeva quella della mente temeva di cedere, disperava di resistere. La sua capacità di lavoro diminuiva ogni giorno: anche stare seduto lo sfiniva. Eppure il pensiero scorreva inarrestabile; però a volte inarrivabile e ne smarriva il filo. Benché agognasse non fare nulla, non voleva (non che non potesse) smettere di lavorare. Si sentiva molto stanco e si sarebbe volentieri goduto quel riposo obbligato e letargico, ma ancora una volta pretendeva un risultato da se stesso. Allora riprendeva la penna, si sforzava di scrivere.
Oh risorgi poesia, e ancora
accompagnami, ombra familiare,
mia poesia agguantata dalla morte...
Così aveva pregato in altri tempi. Adesso non invocava la musa come i poeti antichi; invece le parlava pacatamente, la invitava a frequentarlo e a cantare con le povere parole d’ogni giorno, spoglie e perfino ripetitive, ma giuste
per chi, messo alle strette, in ristrettezze
vive, tra patemi, furie e sulfuree
paturnie – e in vista tenebre e alberi
pizzuti...
  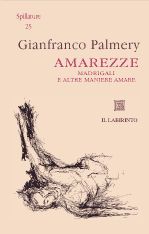  
Progettava nuovi versi che, servi della necessità, ripetessero deliri e scontento, il poco che ancora gli restava dentro e gli urgeva dire. Ne vennero due libri intensi e apparentemente leggeri, antitetici e complementari come corpo e mente: un dittico che riassume in modo esemplare la sua poesia e la sigilla. E in mezzo l’acuta, fervente leggerezza di un amaro libriccino di madrigali, Amarezze, prima che dal suo carcere evadesse per sempre la mente.
O dolce, dolce sonno,
scendi, dilaga in me, spegni la pena,
sciogli nelle tue acque l’amarezza
che lenta mi avvelena.
Morte della mia vita, amata morte,
cuor mio, viscere mie,
– ti piace questa corte
d’amore che squaderna anatomie
alla maniera antica? –
oh ma niente è più mio ma dell’amica!
Sono tutto per te, tutte le vie
ti hanno portato a me, sempre più corte,
così dentro di me
che tu sia la mia vita e io la morte.
 Gianfranco Palmery Gianfranco Palmery
nato a Roma nel 1940 dove ha vissuto, è stato poeta, editore, saggista e traduttore. Ha pubblicato sedici libri di versi e numerose prose sparse in quotidiani e riviste, in parte raccolte in quattro volumi.
Critico letterario per alcuni anni del quotidiano «Il Messaggero», ha fondato e diretto, dal 1984 al 1987, la rivista letteraria «Arsenale». Ha tradotto, per le edizioni Il Labirinto, poesie di Keats, Shelley, Berryman, Sponde, Corbière, Stéfan. Dopo una lunga malattia, è morto a Roma il 28 luglio 2013.
Libri di poesia
- Mitologie, Il Labirinto, Roma 1981.
- L’opera della vita, Edizioni della Cometa, Roma 1986.
- In quattro, Edizioni della Cometa, Roma 1991 (edizione d’arte, con quattro incisioni di Edo Janich).
- Il versipelle, Edizioni della Cometa, Roma 1992 (con prefazione di Luigi Baldacci).
- Sonetti domiciliari, Il Labirinto, Roma 1994.
- Taccuino degli incubi, Edizioni Il Bulino, Roma 1997 (edizione d’arte, con due incisioni di Guido Strazza).
- Gatti e prodigi, Il Labirinto, Roma 1997.
- Giardino di delizie e altre vanità, Il Labirinto, Roma 1999.
- Medusa, Il Labirinto, Roma 2001.
- L’io non esiste, Il Labirinto, Roma 2003.
- Il nome, il meno, Edizioni Il Bulino, Roma 2005 (libro d’artista, con interventi a tempera, grafite, collage e graffiti di Guido Strazza).
- In quattro, Il Labirinto, Roma 2006.
- Profilo di gatta, Il Labirinto, Roma 2008.
- Garden of Delights: Selected Poems, Gradiva Publications, New York 2010 (traduzione e cura di Barbara Carle).
- Compassioni della mente, Passigli, Firenze 2011 (con prefazione di Sauro Albisani).
- Amarezze – Madrigli e altre maniere amare, Il Labirinto, Roma 2012.
- Corpo di scena, Passigli, Firenze 2013.
Prose critiche
- Il poeta in 100 pezzi, Il Labirinto, Roma 2004.
- Divagazioni sulla diversità, Il Labirinto, Roma 2006.
- Italia, Italia, Il Labirinto, Roma 2007.
- Morsi di morte e altre tanatologie, Il Labirinto, Roma 2010.
francescodalessandro@fastwebnet.it
Vedi anche, su questo numero
Poesia, paziente giardiniera. Breve antologia di Gianfranco Palmery
a cura di Patrizia Passarelli
Di e su Gianfranco Palmery su "Fili d'aquilone"
Numero 16
I Soli
silloge poetica di Gianfranco Palmery
Numero 22
Lo specchio Hyerusch e altri prodigi
tre prose di Gianfranco Palmery
Numero 23
GFP
di Annelisa Alleva
|