|
Con gli occhi di bue ho imparato la necessità
del silenzio parlando ogni giorno al vuoto.
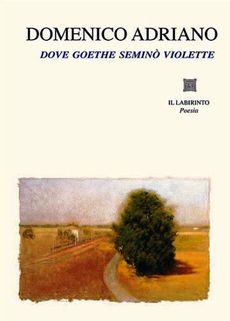 Nel cimitero acattolico di Roma, luogo di sepoltura di tanti stranieri illustri, davanti a una piccola cappella la cui porta sembra aperta sull’eternità, siede una figura femminile lievemente ripiegata su se stessa, i lunghi capelli sciolti sulle spalle. Nel cimitero acattolico di Roma, luogo di sepoltura di tanti stranieri illustri, davanti a una piccola cappella la cui porta sembra aperta sull’eternità, siede una figura femminile lievemente ripiegata su se stessa, i lunghi capelli sciolti sulle spalle.
È la statua della principessa russa Maria Obolensky, morta a Roma nel 1872, a diciassette anni. Ha un’aria tranquilla e melanconica, da cui pare assente ogni ombra di dolore o rimpianto: sembra piuttosto in assorta contemplazione di un orizzonte che stia dentro di lei, e che dallo spazio d’alberi e fiori là intorno, suggestivo nonostante la morte che racchiude, prenda luce. Non è insolito notare tra le sue braccia abbandonate dalle mani congiunte un mazzetto di fiori freschi che un ignoto visitatore penserà a rinnovare quando lo troverà appassito.
Di questa tenera figura di giovinetta, che vive / al giardino dei poeti, dove davanti alla tomba di un figlio Goethe seminò violette, e alla quale Shelley e Keats sono compagni nella sepoltura, dice l’ultimo libro di poesia di Domenico Adriano, Dove Goethe seminò violette, appunto, pubblicato da Il Labirinto in prima edizione nel maggio 2015, e successivamente in versione arricchita nel febbraio 2016.
Chi bussa ora alla porta? / Maria Obolensky è giunta / qui con il pensiero… / Un tempo infinito resta seduta / accanto alla sua dimora, i capelli / sciolti sulle spalle pensose e sul petto, / mani conserte e gli occhi e il viso, / lei che aspetta sempre / sulla porta del Paradiso.
È proprio in quest’angolo in un luogo ristretto e protetto nel cuore di Roma, in cui al di là della morte continuano a fluire le stagioni nelle fioriture e nello sfiorire, che paiono venire a raccogliersi lo spazio e il tempo del poeta: il tempo e lo spazio del luogo natale, e dell’infanzia e della vita adulta, in cui hanno posto i volti, i gesti, le storie raccolte e tesaurizzate nella memoria lungo il cammino, insieme ai frutti della poesia che si è scritta e di quella che dagli scritti di altri si è assorbita.
In questo libro, luminoso di rara felicità poetica, tempo e spazio si sovrappongono in un continuamente rinnovato vivere nel qui e nel presente; ed è proprio la natura profondamente affettiva della memoria del poeta a comporre in unità ricordi separati nel tempo, dettagli ricondotti a un’unica storia compatta e continuamente fluente svolgentesi in uno spazio e in un tempo aperti, popolati di ospiti che sono spesso altri poeti, tanti, Palmery, Cavalli, Bellezza, Riviello… Govoni, Pasolini, Ortesta…
Tutti abbiamo contribuito a costruire / questo libro, mattone dopo mattone, scrive Adriano. Quei “tutti” sono i poeti amati, ma non soltanto: sono tutti coloro che hanno lasciato comunque una traccia, sono gli amici, letterati o no; e sono le immense figure famigliari, possenti nella loro semplicità, la nonna, che viveva di niente, / intrecciando fili d’erba / che sulla sua testa quando passava / diventavano ricami; il padre, testimone della Storia, magico narratore, Me lo raccontò mio padre, / ma a me sembra anche di ricordarlo / bene… / no / io non ero ancora nato ma vidi / all’orizzonte quel che restava la pietraia / dell’Abbazia di Montecassino; la madre, evocata in versi intensissimi: Lei, che prima della mia / nascita non era mai andata oltre / il suo viso, ricorda il giorno / che in visita a una sposa / amica, su un’anta d’armadio / si vide per la prima volta / intera nello specchio che cantava.
Questo paesaggio è popolato d’alberi e di uccelli, elementi primari del cosmo affettivo di Adriano. Il vento e il volo. L’olmo, il fico, l’ulivo, gli alberi umili dello spazio familiare. Gli uccelli, presagio del cielo, il merlo, il pettirosso, la rondine. Albero e uccello, simboli antichi e potenti, portatori di unione tra il continuo e il discontinuo, stormiscono e volano in continuo intreccio con gli esseri umani. A chi posso mia madre assomigliare? / – si chiede Adriano. – / Certo, mio caro Saba, / a un albero, a un / infaticabile albero. Viva, / viene spesso a trovarmi / in sogno, così alta / irrequieta d’uccelli: la chioma / ampia e folta, i capelli / stretti a cercine. / A furia / di dispensare amore, mia madre / si è trasformata in olmo.
Una corrente di inarrestabile metamorfosi innerva questo libro, e vi si scava il letto. La madre-olmo stormisce, irrequieta d’uccelli. La figlia tutta ride come il getto di un ramo. Il fico insieme a una bambina corre a scuola, l’ulivo prova a dirci cos’è una poesia.
Questa agitazione metamorfica si comunica agli stessi testi di cui il libro si compone, che si inseguono e dialogano come dando vita a più ampie forme.
Loro due davanti a me camminano, / le figure un poco sgranano. Il poeta segue i genitori cercando di raggiungerli, in una poesia a pagina 29 del libro. Posso / affrettare il passo. Presto / entreranno in paese, mi aspetteranno?... Ma il mare avanza, rischiando di sommergere il paese. L’acqua sale, ricopre / ormai i fossili di tutte le cave. Ed ecco, molte pagine dopo, Li avevo quasi raggiunti, di nuovo / li persi. Possibile / che andassero così veloci? Presi / per una discesa, l’acqua / saliva, piano…
Il motivo della madre-albero si ramifica in testi diversi che tra loro si raggiungono: mia madre / si è trasformata in olmo, così nella poesia già citata; e altrove, Non riesce a stare ferma mia madre: / un albero può stare fermo? / Tra le fronde dei suoi ottantacinque / anni, all’imbrunire / nuvole d’uccelli cercano un appoggio.
E ancora. Il padre è colui che guida al riconoscimento dei nomi degli uccelli, del loro diverso volo, colui che segnala i passeri, le rondini, i cardellini, i merli, e tuttavia si duole di non capirne la lingua. Ma gli uccelli dove vanno a morire?, si domanda Adriano. Nessuno lo sa, non me lo sa dire / mio padre che li ha amati… / …Quando l’ardore viene a mancare / si lanciano in mare… / afferma. E suo padre, come interponendosi da un altro testo, lo suggerisce, o conferma: E se io fossi un uccello?..... / Avessi le ali, / andrei figlio incontro al mare, in un dialogo sommesso con i versi del figlio: Anche il poeta Vito Riviello / e il mio amico Pasquale Rea, polveri / e luci di aria ora stanno in fondo ai mari.
Forse vi hanno raggiunto l’albatro di Baudelaire.
E sono ancora i motivi dell’albero e dell’uccello a intrecciarsi per segnare nella vita dell’io che scrive l’apparizione epifanica della vocazione alla poesia. Gli occhi del bambino fatti simili al volo degli uccelli intorno ai rami di un fico a strapiombo, volano anch’essi: mi portò un merlo / a un albero giovane snello: / mani e becco a inseguire more, i fichi / alti d’ali e di cielo. / Il bambino si issava sopra i sassi / con gli occhi che volavano coi rami. / Mai sazio della viva / poesia, su fil di lama, / iniziò allora forse / a chiedersi la misura / del verso, quando finì / tra le spine con lo schianto di un ramo.
Dalla viva poesia – intuizione vissuta nell’attimo, e nell’insieme degli attimi, e che basta a se stessa non avendo ancora bisogno di scrittura – all’illuminazione: sentirsi d’improvviso poeta prendendone coscienza nell’attimo stesso in cui inseguendo il volo d’un uccello il bambino precipita da un ramo schiantato.
Raramente la chiamata alla poesia è stata narrata con tale spoglia intensità. Colpisce a questo proposito la profondità con la quale Domenico Adriano pare aver interiorizzato tutta una tradizione letteraria che come nota Roberto Deidier è costituita dalla linea Leopardi-Saba, raggiungendo una sua forma di classicità fatta anche di una assenza di timore che gli permette di scrivere versi che possono sembrare richiami crepuscolari ma che sono lontani da ogni manierismo: Non ho fatto in tempo, signora maestra, / stamattina a svegliare le violette, e E io che ero già malato / mi sono ammalato di bellezza. Una classicità che ci dice molto sul non aver timore davanti alle parole usate in purezza d’intenzione e chiarità di senso: quella stessa che fa rispondere alla bambina cui viene chiesto “Tu lo sai cos’è una poesia?” / …… / “Ma è una storia, mamma!”.
Non si può tacere, infine, sulla presenza della pittura nella poesia di Domenico Adriano. Una presenza discreta e tuttavia indicativa a mio avviso di certi strati di senso che vi giacciono in profondità, e verso i quali qui mi arrischio a scendere.
Leggiamo in questo libro il nome di Rosai, di Antonello da Messina. Si tratta di accenni, di richiami per via di uno scorcio, di un colore. Ma in particolare c’è un quadro di Boccioni cui Adriano si riferisce in una delle sue poesie più misteriose e che richiede di esser riportata per intero: Quando l’ho ritrovata mi ha sorriso. / Stava in fondo a una gola, / su una loggia, persone / trascinate, travolte. / Mi strinse le mani. / Quelli che vanno, quelli che restano: / la nebbia ci avvolgeva / di un quadro di Boccioni. / “Figlio, volevo restare ancora un po’ / con voi, sono diventata vecchia / da soli quattro giorni”.
In questa poesia Adriano usa, se non erro per l’unica volta in tutto il libro, la parola nebbia. Credo sia stata questa parola insolita a spingermi a cercar di guardare, attraverso quei quadri, negli occhi del poeta. Si tratta, in verità, di tre opere di Boccioni che vanno sotto il nome di “Stati d’animo”: e sono “Gli addii”, “Quelli che vanno”, “Quelli che restano”. Il tema della partenza e dell’addio; del movimento e della stasi. Ci si stringe in un abbraccio, poi qualcuno sale su un treno e se ne va; qualcun altro resta sulla banchina e vede il treno allontanarsi.
Gli occhi del poeta vedono nebbia attorno alle figure che vanno e a quelle che restano nei quadri di Boccioni; nei versi la nebbia avvolge invece persone che si stanno venendo incontro e si stringono le mani. Ancora una volta Adriano racconta il movimento, in cui chi va e chi resta è in realtà in transito – come del resto in Boccioni – verso una forma più complessa. Ognuno va, ognuno rimane, tutto si muove.
Sembra allora a me che in questo movimento continuo dell’essere scompaia la morte come stato definitivo; sembra a me che nel fondo di questa poesia la morte stessa sia un’entità fluttuante, che attraversa e riattraversa senza posa lo strato diafano del non esserci più.
Niente di lui si dissolve… – scrive Shakespeare nella Tempesta –, …ma subisce una metamorfosi marina… Così è scritto sulla tomba di Shelley, non lontana da quella della giovanissima Maria.
Domenico Adriano, Dove Goethe seminò violette, Il Labirinto, Roma 2015, 2^ edizione 2016, pp. 88, euro 12.
POESIE DI DOMENICO ADRIANO
da Dove Goethe seminò violette
|
*
Ma gli uccelli dove vanno a morire?
Nessuno lo sa, non me lo sa dire
mio padre che li ha amati:
“Il merlo dell’infanzia
al mio fischio veniva
dal bosco alla finestra, mi era amico”.
E non lo sa il cacciatore
né lo zio contadino. Dove vanno
gli uccelli quando sentono di morire.
Forse in silenzio dormono tra i rovi.
Uno vidi tremante da un rametto
di vinco planare a terra e sparire.
Ricordo il giorno che salii ragazzo
su un carrubo, sicuro
di vedere un nido, era invece una pica
dissolti i suoi novantanove canti
nell’intreccio dei rami.
Ma gli uccelli dove vanno a morire?
Quando l’ardore viene a mancare
si lanciano in mare, o nei bei laghi
dove s’immergono in picchiata.
Anche il poeta Vito Riviello
e il mio amico Pasquale Rea, polveri
e luci di aria ora stanno in fondo ai mari.
*
Vidi con mio padre un fico
a strapiombo in un crepaccio. Intorno
vi volavano uccelli,
nel becco già il seme d’altri viaggi.
Tra i muri di una casa mutilata,
mi portò un merlo
a un albero giovane snello:
mani e becco a inseguire more, i fichi
alti d’ali e di cielo.
Il bambino si issava sopra i sassi
con gli occhi che volavano coi rami.
Mai sazio della viva
poesia, su fil di lama,
iniziò allora forse
a chiedersi la misura
del verso, quando finì
tra le spine con lo schianto di un ramo.
*
Come pioggia battente
veniva giù per il vicolo un pianto
allegro di organetto, si spandeva
per l’aria. Allungai il passo,
altri sopraggiungevano.
Le ali perse nel mantice del canto
un ragazzo suonava per se stesso.
Si accorse di noi, fuggì
inseguendo le note
disciolte. Correvamo
ora tutti verso quelle,
si arrese: chiuse gli occhi, ricatturò
il suo suono a strapiombi.
*
I camini fumavano ma ora
era difficile contare le famiglie
dai fuochi che facevano. Tante braccia
dissodarono le pendici più scoscese,
governarono le acque per piantare
ulivi e vigne. Ogni angolo ogni grotta
era abitata nel più nascosto anfratto.
Ogni appezzato, colmo di sostanze
ereditate dal mare fatto orto.
Ma perché poi contare?
Feci un giro per i Magni, per i Curti,
donne intente all’aperto
a cuocere pomodori mi guardarono
come uno straniero, altre facevano
lucenti le bottiglie con acqua e sabbia
mista a sassolini raccolti dopo la pioggia.
Scesi giù ai Carelli, davanti alla chiesa
avevano acceso nel centro della strada
un falò, pareva una pira,
le fiamme si alzarono al cielo, qualcuno
doveva aver guardato verso la costa,
un cane certo aveva latrato, il gallo
si era messo a cantare alla sera.
*
Tutti abbiamo contribuito a costruire
questo libro, mattone dopo mattone.
Oh sì, quanto vissuta ora
è la casa, e nella grande cucina
da uno spiraglio un raggio
di sole vibra in un gran polverio.
Viavai di amici, cene
ottime, improvvisate. Quadri
poggiati a terra, non importa
se ancora non trovano una parete;
“Il merlo che canta perché vuole fare
l’amore”, “Il sesso di perla e di castagna”
davvero non sappiamo dove metterli.
Chi bussa ora alla porta?
Maria Obolensky è giunta
qui con il pensiero. Prima di morire
dovreste conoscerla, salutare
la sua bellezza. Vive
al giardino dei poeti
dove Goethe seminò violette,
fanno compagnia alla sua
giovane età Shelley e Keats.
Un tempo infinito resta seduta
accanto alla sua dimora, i capelli
sciolti sulle spalle pensose e sul petto.
*
Non per la trasparenza
del vetro ma della mente,
figlia, mi potrai vedere. I colori
e più il rosa dentro il fuoco del ghiaccio
tremeranno al tuo sguardo.
Figlia che cammini così leggera.
Figlia che non ti piaceva il mio paese
perché non c’era il mare.
Allunghi ora il passo mi dai la mano.
Figlia povera che ti fecero
due poeti nell’anima e nel corpo.
Figlia forte più di una montagna.
Figlia che porti
di Antonello da Messina
in te l’azzurro ghiaccio.
|
 Domenico Adrianonato a Coreno Ausonio nel 1948, vive a Roma dal 1965. Ha insegnato per breve tempo nelle scuole elementari. Iniziò a pubblicare i poeti tramite il quotidiano «Lotta Continua». È stato poi titolare, per «Avvenimenti», di una rubrica settimanale che dal 1989 al 2000 ha disegnato una storia della poesia di ogni tempo e di tutte le letterature. Ha curato diverse antologie, la più recente Dall’alto del Gianicolo vedo i Castelli Romani (Poeti a Frascati 1959 –2006)”, Crocetti, Milano 2007, con Arnaldo Colasanti. Suoi testi sono stati tradotti in russo, in inglese, in francese, in spagnolo e in esperanto. Domenico Adrianonato a Coreno Ausonio nel 1948, vive a Roma dal 1965. Ha insegnato per breve tempo nelle scuole elementari. Iniziò a pubblicare i poeti tramite il quotidiano «Lotta Continua». È stato poi titolare, per «Avvenimenti», di una rubrica settimanale che dal 1989 al 2000 ha disegnato una storia della poesia di ogni tempo e di tutte le letterature. Ha curato diverse antologie, la più recente Dall’alto del Gianicolo vedo i Castelli Romani (Poeti a Frascati 1959 –2006)”, Crocetti, Milano 2007, con Arnaldo Colasanti. Suoi testi sono stati tradotti in russo, in inglese, in francese, in spagnolo e in esperanto.
Cinque i suoi libri: La polvere e il miele, Bella e Bosco (premio Libero de Libero), Bambina mattina, Papaveri perversi, Dove Goethe seminò violette (Il Labirinto, 2015, 2ª ed. 2016). Per la cura di Barbara Carle e Michel Sirvent: Bambina mattina, in italiano, in inglese e in francese (Ghenomena, 2013).
tarquini.francesco@fastwebnet.it
|