rivista d'immagini, idee e Poesia

gennaio/marzo 2007
Alterazioni climatiche
| FILI D'AQUILONE rivista d'immagini, idee e Poesia |
 |
Numero 5 gennaio/marzo 2007 Alterazioni climatiche |
|
LA TERRA DI JUAN RULFO IN di Antonella Piperno |
I racconti contenuti nella versione definitiva di El llano en llamas consacrano Rulfo come maestro del cuento per la sua intensità e reticenza comunicativa. I temi principali della raccolta sono la pianura messicana e il fuoco rivoluzionario; Rulfo già nel titolo ce li presenta attraverso un incisivo connubio paronomastico (llano/llamas) che purtroppo non può essere reso in traduzione. Il titolo del testo in italiano è, infatti, La pianura in fiamme, pubblicato la prima volta in Italia nel 1990 da Einaudi, che ora lo sta riproponendo in una nuova traduzione.
I 17 racconti di El llano en llamas si basano sull'essenzialità e sull'implosione. La pianura evoca i sentimenti umani più profondi, ma attraverso rapide descrizioni fotografiche (e Rulfo è stato anche ottimo fotografo) e intense percezioni sensoriali, come si può vedere nell'incipit del racconto En la madrugada:
La personificazione di San Gabriel è un efficace esempio per mostrare l'amore che Rulfo nutre per la sua terra. Il testo è molto lirico nel narrare il risveglio della nebbia e delle nuvole che avvolgono il pueblo e lo cullano in una sorta di abbraccio mattutino. Rivela anche la profonda unità tra l'uomo e la natura che sembrano appartenere, nel loro sonno notturno, a un'unica sostanza. Sul piano stilistico, oltre alla personificazione, Rulfo riproduce la marginalità del suo popolo ricercando l'oralità e il linguaggio colloquiale dei messicani. I dialoghi/monologhi dei suoi personaggi sono pieni di messicanismi nell'ambito della flora (amoles, garambuyos, huizapoles), della fauna (huitacoche, comejenes, zopilotes), della cucina (mezcal, bingarrote, melcocha) e degli utensili della vita quotidiana (petate, comal, chirimía).
Le terre messicane sono "terre di confine", terre di incontro, sofferenza, silenzio e disperazione. La Jalisco di Rulfo è sempre troppo arida o troppo umida; ogni eroe rulfiano sfida quotidianamente una geografia liminare per potersi affermare. L'angoscia di ogni personaggio è quella di essere nato in un territorio in cui il maíz non cresce perché la siccità lo impedisce, in cui il Paese non avanza (o retrocede) perché le miserie umane e i crimini primitivi lo riducono a un livello estremo di degrado e solitudine.
In Nos han dado la tierra, ad esempio, il narratore descrive la frustrazione dei contadini di fronte alla riforma agraria. Dopo una lunga peregrinazione sotto il sole cocente, i campesinos - disarmati e privati dei loro cavalli - scoprono che la ripartizione delle terre è assolutamente squilibrata. Ai contadini spetta il Llano Grande, il blanco terregal endurecido: ettari di terra sterile e desolata. Mentre la tierra buena ha avuto come destinatari quelli che già ne possedevano, i più ricchi! Questa amara ironia si fa sempre più pungente quando il delegado finge persino di accettare proteste scritte. In realtà, siamo di fronte all'ennesima beffa perché tutto è già stato deciso: ai contadini non rimane che lo sconforto. La terra è una questione cruciale anche in El llano en llamas, il racconto che dà il titolo dell'intera raccolta, dove emergono le atrocità di ogni guerra: omicidi, violenze, fughe, incendi. Le llamas della rivoluzione non sono qui una metafora per descrivere l'ardore dei rivoluzionari. Il fuoco carbonizza i morti e gli animali degli indigeni, i campi di mais e riduce in cenere la speranza di un cambiamento effettivo e duraturo. La rivoluzione si presenta nei suoi aspetti più cruenti e alla fine lascia solo strascichi di rancore e di povertà estrema, incancrenita. Basterebbe possedere un pezzo di terra fertile per colmare tale marginalità geografica ed economica e per ridare agli uomini la dignità di cui sono stati privati. Per questo i personaggi rulfiani sono sempre anime nomadi: pellegrini alla ricerca della propria identità o di un residuo di speranza, certo non più rintracciabile nella Revolución o nella religione. Anche la fede, come ci dimostra abilmente Anacleto Morones, è solo religiosità apparente, ecco perché porta gli uomini a tragiche diaspore interiori che sfociano in vendette e menzogne. Il fallimento religioso è da associare all'incapacità di amare. Per questo nei racconti rulfiani l'amore - filiale o coniugale - si presenta sempre come un ulteriore inganno. No oyes ladrar los perros e La herencia de Matilde Arcángel offrono esempi continui dell'implacabile astio tra genitori e figli. In entrambi i testi la narrazione della frammentarietà familiare sfiora il "tremendismo" producendo un effetto straniante nel lettore. In Talpa, invece, il narratore, dopo aver creato un'atmosfera iniziale di apparente normalità, ribalta la situazione per trasformare la devozione e la fedeltà in violenza e tradimento. Concludo con una riflessione sul silenzio e sulla morte, temi centrali nella narrativa di Rulfo. E sì, perché a Luvina, come in seguito nella Comala di Pedro Páramo, paradossalmente è il silenzio a far rumore. Il silenzio è abitato da murmullos, bultos e labili sono i confini tra vita e morte. La laconicità messicana è proverbiale, così come lo strano e intenso rapporto che i messicani hanno con la morte. L'implosività - l'esplosione verbale centripeta, come accennavo all'inizio - non è solo una tecnica stilistica ma è l'essenza messicana. Il silenzio è per Rulfo una regola narrativa e biografica. D'altra parte, il silenzio e l'anonimato sono scelte, abitudini, che derivano da secoli di sfruttamento coloniale e di oppressione fisica e psicologica. Anche per Octavio Paz (v. El labirinto de la soledad) il silenzio è l'unica difesa de "los hijos de la Malinche", e aggiunge: "l'ermetismo è un espediente della nostra rabbia e mancanza di fiducia (...) La durezza e l'ostilità dell'ambiente - e questa minaccia nascosta e indefinibile, che sempre aleggia nell'aria - ci costringono a chiuderci all'esterno".
|
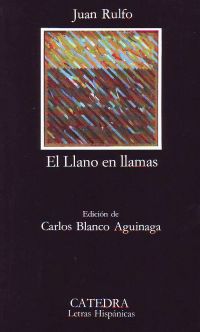
CI HANNO DATO LA TERRA di Juan Rulfo (da La pianura in fiamme)
Dopo aver camminato per tante ore senza trovare nemmeno un'ombra d'albero, né un seme d'albero, né una radice di niente, si sentono i cani abbaiare. Attraverso questo sentiero senza margini, a volte qualcuno arriva a credere che non ci sia niente dopo; che non si troverà niente dall'altro lato, alla fine di questa pianura spaccata da crepe e da ruscelli asciutti. E invece sì, c'è qualcosa. C'è un paese. Si sentono i cani abbaiare e nell'aria si respira l'odore del fumo, e si assapora questo odore di gente come se fosse una speranza. Ma il paese si trova molto più in là. È il vento ad avvicinarlo. Stiamo camminando dall'alba. Adesso sono più o meno le quattro del pomeriggio. Qualcuno osserva il cielo, allunga lo sguardo lì dove è appeso il sole e dice: - Sono più o meno le quattro del pomeriggio. Questo qualcuno è Melitón. Con lui, ci siamo Faustino, Esteban ed io. Siamo in quattro. Io li conto: due avanti, altri due dietro. Guardo più indietro e non vedo nessuno. Quindi mi dico: "siamo in quattro". Poco fa, verso le undici, eravamo più di venti; però a piccoli gruppi gli altri si sono dispersi finché non è rimasto nient'altro che questo nodo che siamo noi. Faustino dice: - Può darsi che piova. Tutti alziamo la faccia e guardiamo una nuvola nera e pesante che passa sulle nostre teste. E pensiamo: "Sì, può darsi." Non diciamo quello che pensiamo. La voglia di parlare ci è già passata da molto tempo. Ci è passata con il caldo. Parleremmo con piacere da qualche altra parte, ma qui è faticoso. Qui se uno parla, le parole si riscaldano nella bocca con il calore di fuori, si seccano sulla lingua e si finisce con l'affanno. Così stanno le cose qui. Per questo a nessuno viene voglia di parlare. Cade una goccia d'acqua, grande, grossa, fa un buco nella terra e lascia una massa molliccia come quella di uno sputo. Cade sola. Noi speriamo che ne cadano ancora e le cerchiamo con gli occhi. Ma non ce n'è più nessuna. Non piove. Ora se si guarda il cielo si vede la nuvola carica d'acqua che corre molto lontano, in gran fretta. Il vento che arriva dal paese le si avvicina spingendola contro le ombre azzurre delle colline. E la terra si mangia la goccia caduta per sbaglio e la fa sparire nella sua sete. Chi diavolo direbbe che questa pianura è tanto grande? A cosa serve, eh? Abbiamo ripreso a camminare. Ci eravamo fermati per vedere piovere. Non ha piovuto. Ora riprendiamo a camminare. E a me sembra che abbiamo camminato più di quanto abbiamo percorso. Mi sembra così. Se avesse piovuto forse mi sarebbero venute in mente altre cose. D'altra parte, io so che da quando ero ragazzo non ho mai visto piovere sulla Pianura, quello che si chiama piovere. No, la Pianura non serve a nulla. Non ci sono né conigli né uccelli. Non c'è niente. A parte qualche macchia sparsa di cespugli spelacchiati e qualche piccola macchia di zacate1 con le foglie accartocciate; a parte questo, non c'è niente. E noi camminiamo qui. I quattro a piedi. Prima camminavamo a cavallo e portavamo una carabina in spalla. Ora non portiamo neppure la carabina. Io ho sempre pensato che hanno fatto bene a toglierci la carabina. Da queste parti è pericoloso circolare armati. Se vedono uno che va in giro tutto il giorno con "la 30" legata alla cintura, lo uccidono senza avvisare. Ma i cavalli sono un'altra storia. Se fossimo venuti a cavallo avremmo già assaggiato l'acqua verde del fiume, e portato a passeggio le nostre pance per le vie del paese per digerire il cibo. Avremmo già fatto queste cose se avessimo avuto tutti i cavalli che avevamo. Ma ci hanno tolto anche i cavalli insieme con la carabina. Mi volto da tutte le parti e guardo la Pianura. Tanta terra e così grande per niente. Gli occhi scivolano non trovando niente che li trattenga. Solo alcune lucertole sporgono la testa dai loro buchi, e dopo aver sentito la calura del sole corrono per nascondersi all'ombra di una pietra. Ma noi, quando dovremo lavorare qui, che faremo per rinfrescarci dal sole, eh? Perché a noi ci hanno dato questa crosta di terra secca per farcela seminare. Ci hanno detto: - Dal paese a qui è vostra. Noi abbiamo domandato: - La pianura? - Sì, la Pianura. Tutta la Grande Pianura. Noi rimanemmo a bocca aperta per dire che non volevamo la Pianura. Che volevamo la terra accanto al fiume. Dal fiume in là, le distese fertili, dove si trovano quegli alberi chiamati casuarinas2 e le paraneras3 e la terra buona. Non questa dura pelle di vacca chiamata Pianura. Ma non ci hanno permesso di dire le nostre cose. Il delegato non veniva certo a conversare con noi. Ci ha messo le carte in mano e ci ha detto: - Non fatevi prendere dal panico di fronte a tanto terreno solo per voi. - È che la Pianura, signor delegato... - Sono migliaia e migliaia di ettari. - Ma non c'è acqua. Non c'è acqua nemmeno per fare un sorso. - E il temporale? Nessuno vi ha detto che vi sarebbero stati dati terreni con l'acqua. Non appena lì si mette a piovere, il mais crescerà come se lo stessero allungando. - Ma, signor delegato, la terra è arida, dura. Non crediamo che l'aratro riesca a conficcarsi in questa spianata sassosa che è la terra della Pianura. Si dovrebbero fare buchi con la zappa per seminare e anche così è certo che non uscirà niente; non crescerà né mais né niente. - Questo mettetelo per iscritto. E ora andatevene. Dovete protestare con il latifondo, non con il Governo che vi dà la terra. - Aspetti, signor delegato. Noi non abbiamo detto niente contro il Centro. Ce l'abbiamo con la Pianura... Non si può fare l'impossibile. Questo abbiamo detto... Aspetti un attimo e chiariamoci. Ricominciamo daccapo. Ma lui non ha voluto ascoltarci. Così ci hanno dato questa terra. E vogliono che seminiamo qualcosa in questo comal4 bollente, per vedere se qualcosa germoglia e cresce. Ma qui non crescerà niente. Nemmeno gli zopilotes5. Ogni tanto si vedono lì, molto in alto, mentre volano in fretta, cercando di uscire il più presto possibile da questo bianco terreno indurito, dove niente si muove e dove si cammina come cadendo all'indietro. Melitón dice: - Questa è la terra che ci hanno dato. Faustino dice: - Che? Io non dico nulla. Io penso: "Melitón non ha tutte le rotelle a posto. Deve essere il caldo a farlo parlare così. Il caldo che gli ha attraversato il cappello e gli ha riscaldato la testa. Altrimenti, perché dice ciò che dice? Quale terra ci hanno dato, Melitón? Qui non c'è nemmeno quel poco di cui il vento avrebbe bisogno per giocare ai mulinelli." Melitón ricomincia a dire: - Servirà a qualcosa. Servirà almeno per far correre le giumente. - Quali giumente? - gli chiede Esteban. Io non avevo fatto molto caso a Esteban. Ora che parla, gli faccio caso. Porta una giacca che gli arriva all'ombelico, e da sotto al giacca spunta la testa di qualcosa simile a una gallina. Sì, sotto la giacca Esteban porta una gallina rossa. Le si vedono gli occhi addormentati e il becco aperto come se sbadigliasse. Io gli chiedo: - Ascolta, Teban, dove hai sgraffignato questa gallina? - È mia - dice lui. - Prima non ce l'avevi. Dove te la sei fregata, eh? - Non l'ho fregata, è la gallina del mio cortile. - Quindi te la sei portata come rifornimento, no? - No, la porto per allevarla. La mia casa è rimasta vuota e senza nessuno che le possa dare da mangiare; per questo me la sono portata. Quando vado lontano me la porto sempre. - Lì nascosta soffocherà. È meglio metterla all'aria. Lui se la sistema sotto il braccio e le soffia l'aria calda della sua bocca. Dopo dice: - Stiamo arrivando al dirupo. Io non sento più ciò che continua a dire Esteban. Ci siamo messi in fila per scendere nel burrone e lui va avanti. Si vede che ha preso la gallina per le zampe e la scuote in continuazione, per non sbatterle la testa contro le pietre. Man mano che scendiamo, la terra diventa buona. Abbiamo sollevato polvere come se fosse una mulattiera il sentiero che scende da lì; ma ci piace riempirci di polvere. Ci piace. Dopo aver calpestato per undici ore la durezza della Pianura, ci sentiamo a nostro agio avvolti in questa cosa che salta su di noi e sa di terra. Sul fiume, sulle verdi chiome delle casuarinas6 volano stormi di verdi chachalacas.7 Anche questo ci piace. Ora i latrati dei cani si sentono qui, vicino a noi, è che il vento che arriva dal paese rimbalza nel burrone e lo riempie con tutti i suoi rumori. Quando ci avviciniamo alle prime case, Esteban ha di nuovo in braccio la sua gallina. Le slega le zampe per fargliele sgranchire, e poi lui e la sua gallina scompaiono dietro a qualche tepemezquites.8 - Io me ne vado da quella parte!- ci dice Esteban. Noi proseguiamo, verso l'interno del paese. La terra che ci hanno dato si trova là sopra.
1Erba perenne - caratteristica delle zone calde del Sud America - il cui colore varia dal verde all'azzurro. |
|
Titolo originale del racconto: "Nos han dado la tierra".
Traduzione e note di Antonella Piperno
|
Sulla letteratura messicana vedi anche, su questo numero:
Jorge Ibargüengoitia, Le morte Acqua e terra: i paesaggi poetici di José Emilio Pacheco
di Alessio Brandolini
di Alessio Brandolini