|
I
 La scomparsa di Umberto Eco ci ha fatto sentire un grande vuoto. Anche perché è stato autore di un best-seller paradossalmente ripudiato, allorché gli veniva ricordato come sua opera per antonomasia. Quando veniva confuso con essa. Non amava essere ricordato come autore solo de Il nome della rosa. Non amava neanche sentirsi dire che quel libro era stata la sua inventio più riuscita, e questo è comprensibile: un artista non vuole essere identificato con una sola sua faccia. Come in una foto che ti raggela in quella frazione di tempo e ti consegna allo sguardo indifferente o tutt’al più limitato da quella parzialità, della gente. La complessità dell’essere rivendica i suoi diritti. In realtà il romanzo al passato deve ad Eco un grande ritorno di popolarità, e questo, volente o no Eco, ha come data d’inizio, anzi, di ripresa, Il nome della rosa (1980). Dopo anni di oblio, abbazie, monasteri, torri, biblioteche più o meno proibite tornavano ad essere il centro di un discorso che doveva riservare ancora delle sorprese e, non è poco, un rilevante successo editoriale, il che vuol dire milioni di copie vendute in tempi in cui si lamentava già la crisi della lettura intelligente, non tanto e non solo del libro. La scomparsa di Umberto Eco ci ha fatto sentire un grande vuoto. Anche perché è stato autore di un best-seller paradossalmente ripudiato, allorché gli veniva ricordato come sua opera per antonomasia. Quando veniva confuso con essa. Non amava essere ricordato come autore solo de Il nome della rosa. Non amava neanche sentirsi dire che quel libro era stata la sua inventio più riuscita, e questo è comprensibile: un artista non vuole essere identificato con una sola sua faccia. Come in una foto che ti raggela in quella frazione di tempo e ti consegna allo sguardo indifferente o tutt’al più limitato da quella parzialità, della gente. La complessità dell’essere rivendica i suoi diritti. In realtà il romanzo al passato deve ad Eco un grande ritorno di popolarità, e questo, volente o no Eco, ha come data d’inizio, anzi, di ripresa, Il nome della rosa (1980). Dopo anni di oblio, abbazie, monasteri, torri, biblioteche più o meno proibite tornavano ad essere il centro di un discorso che doveva riservare ancora delle sorprese e, non è poco, un rilevante successo editoriale, il che vuol dire milioni di copie vendute in tempi in cui si lamentava già la crisi della lettura intelligente, non tanto e non solo del libro.
II
Parlare di abbazie nel romanzo moderno, però, significa tornare ad un archetipo narrativo: il romanzo gotico. Chi si aspettasse di rintracciare le coordinate di una visione ironica, demistificante, scettica e citazionale del medioevo e dei suoi luoghi eccellenti, nel romanzo post-storico, o come ho proposto di chiamarlo in un lontano volume, romanzo al passato{1} del Novecento, come appunto l’echiano Il nome della rosa, resterebbe deluso. Le date del sorriso indulgente, della satira, del compatimento ironico e della parodia non appartengono alla letteratura demistificante dei nostri tempi, ma debbono essere spostate indietro di due secoli.
Una delle colpevoli di tanta lesa maestà è stata l’elegante e compassata Jane Austen, che compose L’abbazia di Northanger nel 1803, e che non si dolse troppo di non averlo mai visto edito: la pubblicazione avverrà qualche mese dopo la sua morte, nel 1818, grazie all’editore Murray. È stato il romanzo meno noto e fortunato della Austen. Lo stesso editore, che pure aveva fatto pressioni per avere il manoscritto, rimase deluso, perché era un romanzo sul romanzo, cui il pubblico non era ancora abituato, e costituiva una presa in giro del novel of sensibility ma soprattutto del romanzo gotico, in primis Ann Radcliffe. Ed era perciò un attentato alla gallina – il romanzo gotico – dalle uova d’oro. E nessun editore avrebbe voluto darsi la zappa sui piedi pubblicando una sottile parodia del genere, che stava fruttando molto bene.
Ma andiamo per ordine. L’archetipo del gothic revival, Il castello di Otranto, di Horace Walpole, era stato scritto qualche decennio prima, e pubblicato in 500 copie, il 24 dicembre 1764, (Pamela di Richardson aveva visto la luce, sempre in Inghilterra nel 1740) senza il vero nome dell’autore, come talvolta capitava in quel periodo. Adottava l’abusata finzione di essere una traduzione da un manoscritto, trovato nell’Inghilterra del nord, nella biblioteca di una famiglia cattolica, ma che era stato già stampato a Napoli nel 1529. I luoghi sono già quelli che saranno topici nella tradizione che si sarebbe sviluppata subito dopo, ma qui sono importanti soprattutto le connotazioni, perché la strategia degli spazi nella letteratura{2} non ha un puro valore denotativo e informativo, ma anche simbolico, ideologico latu sensu: qui ci sono castelli e cappelle, ma quello che colpisce è il sottosuolo, il labirinto dell’untergrund, il magma dell’indistinto che preme per uscire attraverso le sue concrezioni umane: il delitto, la violenza, le dantesche superbia e avarizia, e che però rappresenta anche il passaggio di salvezza verso la fede, il luogo della luce divina. Ancora una volta una ripresa dantesca: solo attraverso l’espiazione nel buio degli inferi, il luogo delle trasformazioni alchemiche, e quindi spirituali, si può capire il senso della vita umana e giungere all’espiazione e alla salvezza.
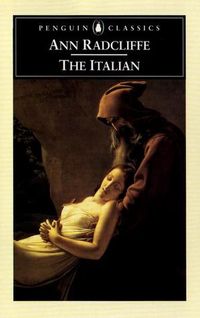 Nel 1797, tre anni dopo I misteri di Udolpho, uscirà L’italiano, di Ann Radcliffe, ambientato in parte a Napoli, nella chiesa di Santa Maria del Pianto, annessa al convento detto dei penitenti neri. Siamo nell’epoca del grand tour, quando la rovina era il naturale luogo mediterraneo, e anche qui abbiamo tracce del passaggio del tempo, che rivela l’antichità del luogo: ovviamente, per la casistica del genere, la chiesa, oltre che antica, è immersa in una inquietante oscurità. Tutto il luogo è pervaso da tenebre. Gli stessi colori delle vetrate, che sarebbero destinati a dare luce agli interni, gettano invece una inquietante ombra. Il confessionale che attira l’attenzione dei visitatori all’inizio del romanzo, è fatto di legno scurissimo. Nel racconto appare, ancora una volta, il pretesto del manoscritto, una narrazione nella narrazione, nella quale vi è ancora una chiesa, quella di San Lorenzo. E vi è ancora un altro luogo sacro, il convento, sempre napoletano, di Santo Spirito. Inoltre assistiamo alla descrizione di conventi-prigioni isolati sulla cima di aguzze montagne che nascondono orribili segreti e vite sradicate con la violenza dalla libertà e dagli affetti. Solo la natura sembra possedere una funzione rasserenatrice di fronte alle sventure, la natura selvaggia dei monti dell’Appennino tra Napoli e L’Aquila. Qui si ha la possibilità di riconoscere il peso delle letture ossianiche della Radcliffe: Nel 1797, tre anni dopo I misteri di Udolpho, uscirà L’italiano, di Ann Radcliffe, ambientato in parte a Napoli, nella chiesa di Santa Maria del Pianto, annessa al convento detto dei penitenti neri. Siamo nell’epoca del grand tour, quando la rovina era il naturale luogo mediterraneo, e anche qui abbiamo tracce del passaggio del tempo, che rivela l’antichità del luogo: ovviamente, per la casistica del genere, la chiesa, oltre che antica, è immersa in una inquietante oscurità. Tutto il luogo è pervaso da tenebre. Gli stessi colori delle vetrate, che sarebbero destinati a dare luce agli interni, gettano invece una inquietante ombra. Il confessionale che attira l’attenzione dei visitatori all’inizio del romanzo, è fatto di legno scurissimo. Nel racconto appare, ancora una volta, il pretesto del manoscritto, una narrazione nella narrazione, nella quale vi è ancora una chiesa, quella di San Lorenzo. E vi è ancora un altro luogo sacro, il convento, sempre napoletano, di Santo Spirito. Inoltre assistiamo alla descrizione di conventi-prigioni isolati sulla cima di aguzze montagne che nascondono orribili segreti e vite sradicate con la violenza dalla libertà e dagli affetti. Solo la natura sembra possedere una funzione rasserenatrice di fronte alle sventure, la natura selvaggia dei monti dell’Appennino tra Napoli e L’Aquila. Qui si ha la possibilità di riconoscere il peso delle letture ossianiche della Radcliffe:
Camminarono in silenzio fino alla cappella di San Sebastiano. Il paesaggio sembrava accordarsi all’umore di Elena. Era una serata buia e il lago, riversandosi in onde scure sulla spiaggia, sommava i suoi fruscii cupi a quelli del vento, che piegava gli alti pini e sibilava sulla scogliera.{3}
(Il corsivo è nostro)
Nella cappella presso Celano dove viene tentata nascostamente la celebrazione di un matrimonio:
Un silenzio assoluto, e una sorta di fioca luce sepolcrale regnavano all’interno.{4}
Come si diceva in apertura, nell’Abbazia di Northanger della Austen è presente già un primo tentativo di contestazione e de-contestualizzazione attraverso l’uso della citazione come accusa di anacronismo, compreso il celebre sintagma, già mosso da volontà ironica e demitizzante, della Austen “La notte fu tempestosa”{5} che tanto avrebbe fatto parlare nell’ultima fase del Novecento, (anche se il sintagma ha avuto riprese prima di Eco, in Paul Clifford, un racconto di Edward Bulwer-Lytton edito nel 1830, e poi nei Tre moschettieri (1844) di Dumas, ma anche dopo Il nome della rosa, nel 2003, in Constance contro tutti di Ray Bradbury) soprattutto l’Eco delle Postille al nome della rosa.
L’abbazia che l’eroina, anzi, una prima forma di anti-eroina, si trova ad abitare, è un coacervo di luoghi comuni e di citazioni più o meno classiche, che provengono soprattutto, ma ormai è lei l’idolo polemico della Austen, dalla Radcliffe:
Il vento era cresciuto di intensità a intervalli per l’intero pomeriggio (…) Catherine, attraversando l’atrio, ascoltò timorosa la tempesta e quando ne udì la violenza attorno all’angolo dell’antico edificio e udì sbattere con improvvisa furia una porta lontana, per la prima volta provò la sensazione di essere veramente in un’abbazia… sì, questi erano i suoni caratteristici di un’abbazia.{6}
In poche parole la Austen usa parodicamente l’espediente dell’effetto al posto della causa, della citazione al posto della realtà: la protagonista scopre di essere in un’abbazia grazie alla corrispondenza tra alcuni particolari delle sue letture “gotiche” e i suoni che realmente si avvertono. Non vive la realtà, ma, come le eroine del grande romanzo ottocentesco, Anna Karenina, Emma Bovary, e anche la Marina di Malombra, la legge attraverso i libri.
Anche l’espediente del manoscritto ritrovato viene contaminato con il ritrovamento di “una lista di biancheria in caratteri rozzi e moderni”.{7} L’esterno dell’abbazia, che la protagonista può vedere solo dopo alcune ore, è certamente trattato in modo più “rispettoso”:
Fu colpita, comunque, al di là di ogni sua aspettativa, dalla grandiosità dell’abbazia, quando per la prima volta la vide dall’esterno. L’edificio includeva un vasto cortile e due lati del quadrato, ricco di ornamenti gotici, erano in evidenza in tutta la loro bellezza, mentre il rimanente era celato da boschetti di vecchi alberi o da piante lussureggianti e le ripide colline boscose che si innalzavano a proteggerlo erano belle anche in quel mese di marzo così spoglio. Catherine non aveva mai visto nulla di simile e provò una grande gioia: senza aspettare l’appoggio di nessuna autorità superiore espresse con impeto tutta la sua meraviglia e la sua ammirazione.{8}
 È intanto da notare, ancora una volta, l’espediente dell’uso della metonimia con l’effetto umoristico dell’inversione dei caratteri realistici: il gotico emerge direttamente dalla descrizione della voce narrante, non dall’atmosfera o dalle supposizioni inferenziali dei personaggi. Non è più evocato dall’atmosfera, dalla suggestione, da una strategia di coinvolgimento, ma viene brutalmente enunciato, e perciò liquidato, come materiale di riporto, scenario, sfondo, citazione di altri tempi, anche se non lontani. I caratteri del romanzo gotico anche qui vengono in parte stravolti, e la serietà dell’enunciazione è parodizzata da due componenti: il fatto che la fanciulla stavolta osi esprimere i suoi sentimenti senza l’appoggio di citazioni e in ogni caso di autorità “superiori”, dall’altra la contestazione dell’abbazia gotica paurosa e buia, qui immersa nella luce primaverile. Ma il romanzo gotico ora, sembra dire la Austen, non è più che un tic, un capriccio nostalgico, che non contiene più, e non ha mai contenuto, la vita. Il realismo è da cercare in tutt’altri orizzonti. Vi è di più: non si tratta di attacchi agli epigoni, ma al gotico in sé e per sé: È intanto da notare, ancora una volta, l’espediente dell’uso della metonimia con l’effetto umoristico dell’inversione dei caratteri realistici: il gotico emerge direttamente dalla descrizione della voce narrante, non dall’atmosfera o dalle supposizioni inferenziali dei personaggi. Non è più evocato dall’atmosfera, dalla suggestione, da una strategia di coinvolgimento, ma viene brutalmente enunciato, e perciò liquidato, come materiale di riporto, scenario, sfondo, citazione di altri tempi, anche se non lontani. I caratteri del romanzo gotico anche qui vengono in parte stravolti, e la serietà dell’enunciazione è parodizzata da due componenti: il fatto che la fanciulla stavolta osi esprimere i suoi sentimenti senza l’appoggio di citazioni e in ogni caso di autorità “superiori”, dall’altra la contestazione dell’abbazia gotica paurosa e buia, qui immersa nella luce primaverile. Ma il romanzo gotico ora, sembra dire la Austen, non è più che un tic, un capriccio nostalgico, che non contiene più, e non ha mai contenuto, la vita. Il realismo è da cercare in tutt’altri orizzonti. Vi è di più: non si tratta di attacchi agli epigoni, ma al gotico in sé e per sé:
Per quanto fossero affascinanti le opere della signora Radcliffe, e affascinanti anche quelle dei suoi imitatori, forse (la protagonista) non doveva cercare in loro la rappresentazione veritiera della natura umana.{9}
Nel 1796 aveva visto la luce il famigerato The monk, di Matthews Gregory Lewis, che segna uno dei non rari casi di identificazione tra personaggio e scrittore, che infatti, dopo il successo del romanzo verrà chiamato Monk Lewis. Anche qui ci viene presentata subito, quasi a garanzia che la merce esposta nel romanzo è quella canonica e che la narrazione non si discosterà dal modello ormai affermato, una abbazia, stavolta spagnola. Qui però manca la connotazione ossianica e tenebrosa, che peraltro opererà più avanti, e con drammatica ostentazione, sebbene una sorta di piccolo attacco “ideologico” ad un culto ormai divenuto, per un anglicano, ostentazione, pura forma, civetteria:
La campana dell’abbazia suonava da appena cinque minuti e già la chiesa era gremita d’ascoltatori. Non ci si deve fare l’idea che quella folla si fosse riunita per motivi di pietà o sete d’informazione. Soltanto pochissimi erano influenzati da tali ragioni; e in una città come Madrid, dove la superstizione regna con così dispotica imposizione, sperare di trovare la vera devozione sarebbe un tentativo inutile.{10}
Per il resto, paesaggio e interni sono puro sfondo per le peripezie, i colpi di scena, gli svelamenti, le malvagità demoniache perpetrate in una Spagna dove l’unica religione, insinua Lewis, è quella della conquista amorosa, della seduzione fine a se stessa, della finzione.
III
Poi verrà Manzoni, ma soprattutto arriverà una pletora incredibile e impossibile da tradurre in numeri, di romanzi “storici”, da Giacosa a D’Azeglio, che testimonierà l’ulteriore evoluzione del romance che ormai è narrazione di fatti strani ma non oltre-umani, quindi di fatto novel storico o di costume. Manzoni riesce magistralmente a tener ferma la componente storica, grazie alle sue puntualissime letture delle cronache milanesi, senza farsi prendere la mano dall’intenzione di parlare anche dell’Italia sua contemporanea, e quell’anche non è da poco, perché rappresenta uno sforzo inaudito – e riuscito – di garantire attualizzazione metaforica e rispetto della storicità. Uno sforzo che pagherà con la singolare auto-accusa, una vera e propria ritrattazione, contenuta nel saggio Del romanzo storico, nel quale egli attacca frontalmente quel genere decretandone l’illusorietà e l’inutilità, in quanto tiene insieme due elementi, la finzione e la storia, che insieme proprio non possono, secondo lui, stare.
 E però il fascino abbaziale sopravvive nell’Ottocento anche in quegli scrittori che non hanno nessuna intenzione di corteggiare il gothic-revival, né di fare un uso strumentale dell’abbazia benedettina, ponendola anzi come luogo fondante e centrale nelle loro narrazioni. È il caso di Antonio Fogazzaro e del suo romanzo Il Santo, che apre il lungo elenco di ritorni all’abbazia, al convento, alla chiesa, al palazzo antico del Novecento. L’autore di Piccolo mondo antico ci mette parecchio tempo: lo inizia nell’estate del 1901, come si legge nell’autografo originale, fino all’estate del 1905 a Roma. Quando il suo personaggio in fuga dal mondo, Piero Maironi, decide di andare a san Benedetto a Subiaco, anche il suo creatore se ne va nella cittadina laziale a studiare i luoghi e abiterà lì e a Jenne, dove si svolge un episodio del romanzo. Romanzo che esce nel novembre del 1905 a Milano per Baldini e Castoldi, ponendo fine ad una attesa spasmodica che si era diffusa negli ambienti intellettuali italiani, per poi incappare nella messa all’Indice con decreto del 5 aprile 1906. Ma a noi interessano i luoghi. Non è un romanzo storico, perché narra nello stesso tempo una crisi di coscienza e uno dei motivi del dibattito religioso di allora, il modernismo. Il racconto è libero dalle pastoie della credibilità storica a tutti i costi e allora può lasciare spazio alla natura, quella che circonda i monasteri benedettini di Subiaco, che spesso assume caratteristiche umane, in una sorta di panismo sfrondato dai compiacimenti estetizzanti di D’Annunzio: le rovine della villa di Nerone sono divise dal “pianto dell’Aniene” e E però il fascino abbaziale sopravvive nell’Ottocento anche in quegli scrittori che non hanno nessuna intenzione di corteggiare il gothic-revival, né di fare un uso strumentale dell’abbazia benedettina, ponendola anzi come luogo fondante e centrale nelle loro narrazioni. È il caso di Antonio Fogazzaro e del suo romanzo Il Santo, che apre il lungo elenco di ritorni all’abbazia, al convento, alla chiesa, al palazzo antico del Novecento. L’autore di Piccolo mondo antico ci mette parecchio tempo: lo inizia nell’estate del 1901, come si legge nell’autografo originale, fino all’estate del 1905 a Roma. Quando il suo personaggio in fuga dal mondo, Piero Maironi, decide di andare a san Benedetto a Subiaco, anche il suo creatore se ne va nella cittadina laziale a studiare i luoghi e abiterà lì e a Jenne, dove si svolge un episodio del romanzo. Romanzo che esce nel novembre del 1905 a Milano per Baldini e Castoldi, ponendo fine ad una attesa spasmodica che si era diffusa negli ambienti intellettuali italiani, per poi incappare nella messa all’Indice con decreto del 5 aprile 1906. Ma a noi interessano i luoghi. Non è un romanzo storico, perché narra nello stesso tempo una crisi di coscienza e uno dei motivi del dibattito religioso di allora, il modernismo. Il racconto è libero dalle pastoie della credibilità storica a tutti i costi e allora può lasciare spazio alla natura, quella che circonda i monasteri benedettini di Subiaco, che spesso assume caratteristiche umane, in una sorta di panismo sfrondato dai compiacimenti estetizzanti di D’Annunzio: le rovine della villa di Nerone sono divise dal “pianto dell’Aniene” e
Alcune stelle brillavano sul roccioso dorso grigio macchiato di nero e il loro lume oscuro mostrava nel chiostro il piazzale, gli arboscelli sparsi, la torre possente dell’Abate Umberto, le arcate, le mura vecchie di nove secoli (…) Il chiostro e la torre si affermavano nella notte con maestà di potenza. Era proprio vero che stessero morendo? Nel lume delle stelle il monastero pareva più vivo che nel sole, grandeggiava in una mistica comunione di senso religioso con gli astri. Era vivo, era pregno di effluvi spirituali diversi, confusi in una persona unica, come le diverse pietre tagliate e scolpite a comporre la unità del suo corpo, come diversi pensamenti e sentimenti in una coscienza umana. Le vetuste pietre, sature di anime commiste ad esse in amore, sature di desideri santi e di santo dolore, di gemiti e preci, radiavano un che di oscuro, penetrante nel subcosciente. {11}
È una sorta di anima cosmica quella che si rivela in una sua parte, il monastero di santa Scolastica, al di là delle possibili interpretazioni, abbondantemente datate, di panteismo e panismo. È probabile che l’accezione di creazione fosse, in un Fogazzaro sensibile ad alcuni temi mutuati da una parte del pensiero modernista, letta in senso di presenza divina anche nelle cose del mondo, di natura vista come traccia della creazione divina. Non è un caso che Benedetto-Piero affermi che “Dio è nella voce dell’Aniene che dalla sera della mia partenza da Jenne mi dice ‘Roma, Roma, Roma’”. E più avanti ancora: “O Aniene, Aniene, come non ti stanchi di ruggirmi il tuo comando!” e “Tu mi dici di obbedire alla voce di Dio nell’Aniene.”{12} Certo vi sono delle descrizioni vicine ai canoni dell’ekphrasis
Lo seguì fino alla cappella che chiamano la chiesa superiore. Colà, di fronte alle tre piccole ogive che chiudono interne ombre dove si disegna un altare e una croce di argento brilla su parvenze fosche di pitture antiche, Jeanne s’inginocchiò, com’egli accennolle, sull’inginocchiatoio appoggiato al fianco destro della grande arcata che gira sulla volta acuta, mentr’egli s’inginocchiava su quello appoggiato al fianco sinistro. Sul timpano dell’arcata un pittore del secolo XIV ha dipinto il poema del massimo Dolore. Da un’alta finestra di sinistra scendeva la luce alla Dolorosa; Benedetto era nell’ombra.{13}
Le descrizioni di Santa Scolastica, di San Benedetto, di Jenne, sono nel Santo emanazioni di una voce interiore che domina al di là dei personaggi del romanzo. Una volta si sarebbe ricorsi all’espediente narratologico del lettore implicito,{14} quello che emana l’idea di mondo alle fondamenta del testo, il che non mi sembra privo di senso, anzi. È probabile che questa idea complessiva di mondo abbia in qualche modo influenzato la decisione di porre il romanzo all’Indice. A quell’altezza cronologica il sospetto di panteismo aleggiava ancora né era facile enuclearlo da concezioni del creato che facevano aggio su un’anima del mondo o sulle tracce nel mondo della creazione divina, come nel caso, due decenni dopo, di Teilhard de Chardin. Fatto sta che qui il monastero benedettino è insieme luogo notturno, il che ha qualche aggancio con il romance di quasi due secoli prima, spazio della meditazione profonda e inizio di una realtà che riuscendo a coniugare lavoro e preghiera ha di fatto rifondato il mondo occidentale dopo la grande e lunga crisi successiva al crollo della compagine statale romana. Non è un caso che una delle prime tappe di Piero-Benedetto sia il dubbio che Dio lo chiami ad entrare nell’ordine per tornare a quell’antica rinascita d’occidente:
Dopo la Comunione ebbi un momento di ansia, parendomi che Cristo mi dicesse nell’anima: non intendi, non intendi, non intendi? Passai la giornata in un’agitazione continua, benché cercassi di affaticarmi più del solito nell’orto. Nel pomeriggio stetti un poco a leggere sotto il leccio dove si raccolgono Loro padri. Avevo Sant’Agostino: «De opere monachorum». Passa gente sulla strada alta, discorrendo forte. Io alzo il viso, meccanicamente. Poi, non so perché, invece di riprendere la lettura, chiudo il libro, mi metto a pensare. Pensavo a quello che scrive Sant’Agostino del lavoro manuale dei monaci, pensavo alla Regola di san Benedetto, a Rancé, e come si potrebbe ritornare, nell’Ordine benedettino, al lavoro manuale. Poi, in un momento di stanchezza, avendo però in cuore quella grandezza immensa di Sant’Agostino, ho creduto proprio di udire una voce dalla strada alta: «MAGISTER ADEST ET VOCAT TE (in caratteri maiuscoli nel testo, ndr)».{15}
Duplice luogo di rinascita, il monastero benedettino ne Il Santo, ma anche luogo di dubbi e di gerarchie che rischiano di perdere contatto con il mondo e di entrare in un processo inarrestabile di decadenza, ed è questo il motivo di quella improvvisa domanda nel monologo di Benedetto che abbiamo prima citato: “era proprio vero che stessero morendo?”.
IV
 Tra le remore del 1850 che portarono Manzoni a decretare l’impossibilità dei componimenti misti di storia e d’invenzione, come recitava il titolo del saggio che pone fine alla sua carriera di romanziere, e Il Santo passano oltre 50 anni. Fogazzaro sarebbe passato indenne sotto i fulmini manzoniani, perché, lo abbiamo notato, il suo romanzo non vuole essere – e non è – un romanzo storico. Ma il romanzo al passato non è mai morto e nel Novecento si riaffaccia di nuovo. Non negli anni che ci aspetteremmo, quelli dell’esposizione mediatica con l’uscita del Nome della rosa e con il seguito di imitatori o innovatori che ne è scaturito. Un notevole esempio di ripresa di racconto storico è rappresentato da un romanzo uscito nel 1936, riedito altre tre volte e poi caduto nel dimenticatoio. Stiamo parlando de La città murata di Igino Giordani, uomo politico e giornalista tra i più importanti del nostro Novecento ed esponente di primo piano del cattolicesimo italiano. Una trasgressione, grave, perché perpetrata da un cattolico, rispetto all’interdizione manzoniana dell’ibrido del romanzo storico. Il racconto di Giordani osa quindi trasgredire l’anatema sul romanzo storico del maestro e ripropone proprio ciò che il Lombardo riteneva non potesse stare insieme, il nesso invenzione-fantasia; in realtà, a parte qualche imprecisione, la ricostruzione storica è accurata: i personaggi si aggirano in un undicesimo secolo ben caratterizzato anche attraverso i minimi particolari, quelli più legati al micro-sistema dei luoghi del Latium Vetus, ma d’altronde Giordani era tiburtino e conosceva bene la storia dei luoghi narrati nella Città murata. Tra le remore del 1850 che portarono Manzoni a decretare l’impossibilità dei componimenti misti di storia e d’invenzione, come recitava il titolo del saggio che pone fine alla sua carriera di romanziere, e Il Santo passano oltre 50 anni. Fogazzaro sarebbe passato indenne sotto i fulmini manzoniani, perché, lo abbiamo notato, il suo romanzo non vuole essere – e non è – un romanzo storico. Ma il romanzo al passato non è mai morto e nel Novecento si riaffaccia di nuovo. Non negli anni che ci aspetteremmo, quelli dell’esposizione mediatica con l’uscita del Nome della rosa e con il seguito di imitatori o innovatori che ne è scaturito. Un notevole esempio di ripresa di racconto storico è rappresentato da un romanzo uscito nel 1936, riedito altre tre volte e poi caduto nel dimenticatoio. Stiamo parlando de La città murata di Igino Giordani, uomo politico e giornalista tra i più importanti del nostro Novecento ed esponente di primo piano del cattolicesimo italiano. Una trasgressione, grave, perché perpetrata da un cattolico, rispetto all’interdizione manzoniana dell’ibrido del romanzo storico. Il racconto di Giordani osa quindi trasgredire l’anatema sul romanzo storico del maestro e ripropone proprio ciò che il Lombardo riteneva non potesse stare insieme, il nesso invenzione-fantasia; in realtà, a parte qualche imprecisione, la ricostruzione storica è accurata: i personaggi si aggirano in un undicesimo secolo ben caratterizzato anche attraverso i minimi particolari, quelli più legati al micro-sistema dei luoghi del Latium Vetus, ma d’altronde Giordani era tiburtino e conosceva bene la storia dei luoghi narrati nella Città murata.
Il romanzo ha dei protagonisti apparenti, due giovani che alla fine, secondo il dettato manzoniano, stavolta condiviso, si sposeranno, ed uno latente, che gli strutturalisti avrebbero chiamato ostensivo, vale a dire che informa di sé il novel anche quando non appare, Ildebrando di Soana prima di diventare Gregorio VII. La Chiesa è in balìa di divisioni, i partigiani della sua sottomissione al potere temporale dell’imperatore ma soprattutto dell’aristocrazia romana sembrano avere la meglio, Tivoli, la città in cui si svolge l’azione, è letteralmente divisa in due (di qui il titolo) da un muro. Ildebrando, Pier Damiani ed altri lottano, pur essendo in assoluta minoranza, per la riedificazione di una Chiesa finalmente libera dalle remore politiche. Il monachesimo benedettino qui ha una importanza notevole: è alleato di Ildebrando, offre i suoi monasteri, quelli del Soratte, di Tivoli, della Mentorella, di Cassino, di Roma come riparo e luogo di riunioni ai rinnovatori. La strategia narrativa e assiologica è, apparentemente, opposta a quella che sarà del Nome della rosa, o ai Dodici abati di Challant di Laura Mancinelli: l’antico vigore delle origini benedettine è ancora vivo, ed è esempio di spiritualità e nel contempo di pratica azione contro la corruzione e la depravazione, anche intellettuale, della Roma che aveva conosciuto l’esperienza e la vergogna, per la Chiesa, di Marozia. Le descrizioni dei luoghi non sono mai neutrali, ma servono al narratore per impostare il discorso assiologico dei valori contrapposti, vale a dire bellezza celeste-monastero-purezza vs corruzione del mondo-cultura estetizzante e fine a se stessa-vescovati luoghi sottomessi al potere politico e al puro interesse materiale. Si prenda la descrizione dei monasteri sublacensi:
A poca distanza dalla sorgiva, il fiume, breve e rapido, dirocciano tra sassi e boschi, si faceva benedettino: cioè lambiva il sacro Speco, dove il grande padre Benedetto aveva passato gli anni della santità giovine e da cui aveva riguardato, tante volte, in meditazione, le cascatelle dirompentesi tra le pietre, circonfuse di spruzzi.{16}
Come era accaduto trent’anni prima con Fogazzaro, sembra che quelle zone trasmettano agli scrittori la capacità di animare l’inanimato, e anche qui è l’Aniene, che ruggiva assieme alla tentazione dell’amore che ritorna dopo la scelta del deserto in Fogazzaro, a prendere caratteristiche antropiche, a “maturare” come una persona invece che scendere nelle campagne tiburtine:
Dopo si placava, intraprendendo il viaggio della maturità, bagnando vigne, lambendo tenute romane, serpendo sempre più lento tra cave abbandonate di travertino e campagne desolate dalla malaria sino alla confluenza col Tevere; e in esso la sua storia s’estingueva.{17}
Il rinnovamento della Chiesa, in questo libro, è intimamente legato al ritorno della purezza, certamente evangelica, ma anche a quella della riforma benedettina, che ha riportato la dignità del lavoro al centro dell’esistenza di contro al torpore dell’otium tardo-imperiale. Perciò, secondo quella che è un’ottica soprattutto cristiano-orientale, la bellezza dell’officium divino è richiamo e anticipazione della bellezza celeste, il che, guarda caso, è quello che sosterrà l’abate benedettino del Nome della rosa quasi cinquant’anni dopo, ma con altri intenti ideologici da parte dell’autore:
Per tre giorni, dalle torri, che svettavano tra gli elci, le campane chiamarono la folla dei contadini, i quali, con le tuniche più pulite e le anime rimesse a nuovo, salirono e stiparono le tre navate della chiesa di Santa Scolastica, cui il sole colmava d’oro dalle vetriate colorate. E quando i monaci, selva nera canora, intonarono il Te Deum, la folla non stette a sentire: intonò anche lei, con migliaia di voci, il canto di lode; e il giovane abate e il legato ne provarono in brivido, con l’impressione di una scena di paradiso.{18}
Vi è singolare coincidenza tra la visione di Piero-Benedetto-Fogazzaro ne Il Santo e quella del narratore in La città murata: ambedue vedono nel ritorno a Benedetto, allo spirito originale dell’ordine, una delle fonti della civiltà a loro contemporanea e dell’occidente intero, e d’altronde anche storici laici hanno contribuito a veicolare quella rivalutazione non solo religiosa, ma economica, della rinascita benedettina.
V
Molti altri scrittori, dopo Giordani, si sono dedicati al medioevo, alcuni dei quali, se non direttamente ai monasteri anche ma non solo benedettini, sono stati interessati alle problematiche religiose, talvolta anche in senso oppositivo.
Italo Calvino, Ferruccio Ulivi, Ignazio Silone, Luigi Malerba, Roberto Vacca, Mario Pomilio, Umberto Eco, Laura Mancinelli e tanti altri hanno parlato, con sfumature diversissime, di medioevo nelle loro creazioni letterarie, continuando una tradizione ultra-centenaria.
I luoghi descritti in questi romanzi, quelli totalmente inventati, quelli dipinti fedelmente e quelli presi a spunto per poi ridefinirli in alcuni particolari, sono ancora una volta, come a fine Settecento, dominati da alcune presenze fondamentali: un castello, una fortezza, un monastero, un convento, una abitazione civile, una abbazia, una sacrestia, una torre: tutte sineddoche di un mondo che non è scomparso del tutto, almeno nell’immaginario collettivo. Una torre merlata è una parte di medioevo, come lo è un castello, o un cavaliere che si staglia solitario in una valle con turrite mura sullo sfondo. La tentazione del richiamo comparativistico è ineludibile, a questo punto, e riguarda il Guidoriccio da Fogliano attribuito a Simone Martini nella sala detta del Mappamondo del palazzo pubblico di Siena negli anni Trenta del Trecento. E con gli anni ci siamo, poiché la finzione del romanzo echiano, tanto per dirne una, è trecentesca, visto che si svolge nel 1327.
È ancora una volta un’abbazia, e sempre benedettina, il luogo raccontato nel più grande successo italiano di questi anni, Il nome della rosa di Umberto Eco. Essa assume, fin dalla descrizione del narratore, il giovane novizio Adso da Melk, una dimensione cosmica, legata, come era proprio dei costruttori di templi in Grecia e in Etruria e poi a quelli delle grandi cattedrali europee dal XII al XIV secolo, alla funzione del microcosmo, figura e anticipazione del macrocosmo divino.
È un esordio primaverile, alla maniera dei trovatori provenzali, ma anche, dirà poi Eco, dei fumetti e della scrittura “degenerata”, serializzata, privata della sua significazione primaria, quello che dà il via al romanzo vero e proprio: “Era una bella mattina di fine novembre”.{19} Dentro la mattina di novembre, un sentiero scosceso, una montagna dalla quale sembra nascere come un suo prolungamento, l’Edificio, la costruzione per eccellenza, che vedremo assommare in sé le meraviglie della conoscenza universale e l’orrore della bestia apocalittica: un edificio che è l’immagine del mondo, con le sue contraddizioni e i tentativi da parte di qualcuno, di trovare un ordine, sempre frustrati da eccessiva fretta o troppa lentezza. Adso pensa di trovare un ordine nell’universo dell’abbazia che possa corrispondere all’ordine celeste, mentre il suo sagace maestro, Guglielmo di Baskerville tenta di dimostrargli, con una costanza che sembra a volte sadismo, che non c’è ordine nell’abbazia, in terra, nelle menti degli uomini, e, forse, neanche in cielo.
Ma andiamo con ordine: Adso, che ha già viaggiato per l’Italia, e conosce Castel del Monte ad Andria e Castel Ursino a Catania, si meraviglia non tanto per le mura, possenti ma simili a tante altre mura, quanto per l’Edificio che le sovrasta.
Dopo la descrizione fisica dell’abbazia e dell’Edificio, Adso, abituato a prefigurare nel qui umano il regno di Dio, si lancia in una dotta disquisizione sulle corrispondenze tra le cose umane e quelle celesti:
Tre ordini di finestre dicevano il ritmo trino della sua soprelevazione, così che ciò che era fisicamente quadrato sulla terra, era spiritualmente triangolare in cielo.{20}
I numeri che stanno alla base dell’armonia costruttiva dell’abbazia tra le alpi liguri e il mare, sono segni, per Adso, di una corrispondenza ideale tra cielo e terra. Il giovane monaco vede quindi l’abbazia con gli occhi dello stesso abate, benedettino come lui: l’edificio appare al giovane monaco il luogo in cui le ricchezze e le reliquie accumulate sono figure delle ricchezze della grazia e della potenza di Dio e, infine, dello splendore dell’al di là.
Nelle pagine iniziali del romanzo, l’abate ordina a Guglielmo di indagare su fatti misteriosi, proibendogli però di aggirarsi nell’ultimo piano dell’edificio, che racchiude la biblioteca. Essa è nel posto più elevato non solo dell’abbazia, ma dell’edificio che in questo racconto prende il posto del mastio, la torre più alta delle fortezze esistenti nella realtà e anche di molti racconti neo-gotici: torre che non sempre nella realtà è disposta sulle mura dei castelli, ma talvolta rappresenta il punto culminante che domina dall’interno. Leonardo da Vinci, nel Codice Madrid II, presenta, per esempio, una fortezza quadrata sormontata da un mastio, vero e proprio edificio, che si erge dal centro del sistema difensivo; anche i disegni per il progetto della rocca di Ravenna, di Antonio da Sangallo, nel XVI secolo, suggeriscono un forte bastione centrale; nel Corteo dei re Magi con Lorenzo de’ Medici, di Benozzo Gozzoli, eseguita a metà Quattrocento nella cappella del palazzo della potente famiglia fiorentina, si nota, sullo sfondo, una cinta muraria con un grande mastio turrito al centro della costruzione. Il sogno-delirio di Ludovico di Baviera aveva immaginato in mezzo alle montagne bavaresi un castello a cinque piani e con una grande torre che dominasse dall’interno tutte le altre; e lo stesso Walter Scott aveva descritto nel suo Ivanohe una fortezza dominata da un torrione di forma quadrata.
Se vogliamo concedere una intenzione figurale alla disposizione spaziale dell’Edificio di Eco e del suo cuore, il Finis Africae, la parte nascosta della biblioteca, dove sono custoditi i codici proibiti, allora ecco che essa appare come culminante, aerea, apicale; segno di dominio e di privilegio perché vicino al Luogo per eccellenza legato, nella teoria degli spazi della scolastica e della filosofia cristiana alla presenza divina: il cielo. La biblioteca quindi, è stata costruita perché rappresenti il punto più lontano dalla materia e più vicino allo spirito, presso la casa di Dio, e per questo più inaccessibile al volgo e a chi vorrebbe far conoscere segreti millenari. Come vedremo Eco sembra contaminare impietosamente questa dislocazione degli spazi, mettendo la biblioteca in diretto contatto – anche simbolico – con le cucine e l’ossario, il luogo dei morti. Ma stavolta non è “colpa” della sua impertinenza “semantica”: in molti monasteri le cucine si trovavano in asse con la biblioteca – come vedremo tra poco anche nel romanzo Il tesoro di Farfa, scritto da un esperto conoscitore di quell’abbazia – per permettere il riscaldamento degli ambienti anche nel rigido clima invernale.
Se la Biblioteca è un labirinto spirituale, è anche un labirinto terreno, dice l’Abate: vi si può entrare, forse, ma certamente non se ne può uscire. Altro segno di connessione allegorica tra cielo e terra: la vita è un breve esilio verso il Luogo dal quale si è un giorno partiti.
Poco più avanti, Adso descrive la chiesa del monastero: essa non è maestosa e slanciata come quelle viste a “Strasburgo, a Chartres, a Bamberga e a Parigi”,{21} ma è vicina a quelle visitate in Italia, poco slanciate, più possenti che alte: è probabilmente un riferimento alle prime abbazie cistercensi, che rappresentarono un punto di equilibrio tra la secolare tradizione romanica e le nuove suggestioni costruttive francesi: Fossanova e Casamari nel Lazio, San Galgano in Toscana, Chiaravalle nelle Marche, tutte consacrate nel XIII secolo, sono un esempio di architettura sacra non ubbidiente passivamente ai nuovi canoni gotici, ma fedele ad una concezione più tradizionale della chiesa, sostenuta da forti e spesse mura, non arricchita da eccessive superfetazioni.
Un nartece protegge il portale, incassato nella forte strombatura del muro che dà l’effetto di profondità all’ingresso: tre colonne dividono in due la soglia d’ingresso, bipartizione presente nelle due chiese di san Francesco ad Assisi, o a Reims, Santiago de Compostela, La Madeleleine a Vezélay, Notre Dame a Parigi e in molte altre costruzioni sacre.
Adso descrive anche gli affreschi della chiesa, che appartengono alla tradizionale raffigurazione del Cristo assiso in trono, circondato dai simboli degli evangelisti, e con ai piedi le acque del Giordano, i seniori dell’apocalisse, i fiori e le piante “di cui si adornano i giardini della terra”,{22} i leoni rampanti, i profeti e gli apostoli Pietro e Paolo. Segue poi una vera e propria catena di citazioni, spesso letterali, dell’Apocalisse di Giovanni, ispirandosi alla quale l’ignoto decoratore della chiesa echiana aveva istoriato le pareti delle volte e Adso sembra colpito e quasi spaventato dalla raffigurazione delle pene infernali.
Per quanto riguarda le grandi opere musive rappresentanti il Cristo assiso, cui si è ispirato Eco, vi sono moltissimi esempi, essendo questo del Salvatore in trono, insieme al pantocrator e alla traditio legis un tòpos assai ricorrente nell’arte romanica: non possiamo tralasciare il mosaico absidale di Santa Maria in Trastevere, iniziato nel 1130, che, pur presentando la variante del Cristo che cinge le spalle della Vergine con il braccio destro, mantiene però lo schema, di cui parla Adso, del libro tenuto sulle ginocchia con la mano sinistra: per Adso il libro è sigillato, per quanto riguarda l’affresco romano il volume si presenta aperto. Nel museo di Sutri è conservato un Cristo assiso e benedicente con il libro poggiato sulle ginocchia e ancora chiuso, ma né l’uno né l’altro hanno la corona di cui parla Adso nella sua commossa rievocazione. A Santa Pudenziana, a Roma, il Cristo è rappresentato seduto in trono, benedicente con la destra e con il libro sulla sinistra, aperto, con intorno apostoli e simboli degli evangelisti, come ricorda Adso, manca però la corona sulla testa del Cristo, che invece appare non in un affresco o in un mosaico parietale o absidale, ma nel timpano marmoreo del portale sud della chiesa romanica (1120 circa) di Saint Pierre a Moissac, peraltro, proprio come afferma Adso, circondato da grandiose raffigurazioni zoomorfe degli evangelisti, che quasi sovrastano il Cristo. Vi è ancora un altro Salvatore incoronato, e per di più avvolto nel nimbo di cui parla Adso, ma è anch’esso un rilievo in pietra, circondato dai consueti simboli degli evangelisti e dai Seniori, nel portale reale della cattedrale di Chartres, costruito dopo il 1145.
Sapremo poi che l’abbazia, vera e propria città-stato autosufficiente, (si confronti la pianta del monastero che Eco allega al romanzo, con una pianta generale dell’abbazia di Cluny e si verifichino alcune affinità: chiesa abbaziale orientata verso est, presenza di edifici cultuali più antichi, pianta della chiesa, come era frequente, a croce latina, disposizione generale dei numerosi edifici), aveva al suo interno, come a Cluny e in altre grandi abbazie, una erboristeria, i bagni (balnea), un ospedale e degli orti. Un cosmo autosufficiente, dove convivono le funzioni materiali del corpo con la dimensione spirituale. C’è chi, come Massimiliano Castellani,{23} giura che le descrizioni corrispondano a quella di un’altra grande abbazia medioevale, che nel Trecento inoltrato però viveva già il suo declino, Farfa. L’autore dell’articolo ricorda una descrizione del Nome della rosa: “Pensa ad un fiume, denso e maestoso, che corre per miglia e miglia entro argini robusti, e tu sai dove sia il fiume, dove l’argine, dove la terra ferma” per concludere che il fiume è il Farfarus citato da Ovidio e “gli argini sono le colline del Reatino che declivano fino a quel lembo di terra ferma che è l’abbazia di Farfa”.{24} Un po’ poco per stabilire una volta per tutte che è proprio e soprattutto Farfa l’abbazia che ispira uno dei romanzi italiani più letti al mondo. Il giudizio dipinto nel 1561 (più di due secoli dopo l’epoca dei fatti nel Nome della rosa) nella controfacciata della chiesa orsiniana di Farfa{25} è nettamente divergente dalla descrizione, fosca e densa di temi tra l’orrido e il metamorfico che fa Adso della scena del giudizio nel romanzo echiano. Sicuramente anche Farfa, perché come ogni storico della letteratura sa, in un romanzo penetrano elementi eterogenei, ricordi mai perfettamente ricostruibili, contaminazioni spaziali e temporali, tanto che spesso gli autori confessano che nella creazione di un unico spazio narrativo hanno concorso – e si sono mescidate – molte suggestioni visive e mnestiche. Anche perché le descrizioni dell’abbazia richiamano altro, una sorta di modello abbaziale costruito, come spesso usava fare Eco, con modelli ma anche con modelli di modelli, con false citazioni di modelli, con citazioni di modelli falsi, e con citazioni di modelli in patte ideati e in parte reali, ma anch’essi mediati dalla metamorfosi e dalla mescolanza.
All’inizio del racconto Adso aveva affermato che l’Edificio, la parte più alta dell’abbazia, gli ricordava Castel del Monte, fortezza di campagna di Federico II, costruita intorno al 1240: in effetti, il castello di Andria presenta otto lati che generano altrettanti bastioni negli angoli d’incontro, e, al suo interno, vi è un cortile di otto lati, una sorta di gran pozzo, proprio come ci ricorda il narratore del Nome della rosa.
Nel torrione meridionale, Adso pone le cucine, che poi, vedremo strettamente raccordate alla Biblioteca, in una commistione di alto e basso, sublime e comico cui deve abituarsi il lettore di questo romanzo: ma, in ogni caso, vi è una spiegazione funzionale: il camino gigantesco della cucina riscalda d’inverno i freddi ambienti e le scale della biblioteca, permettendo ai monaci di lavorare anche quando il sole è tramontato e non riscalda più quei locali. Lo scriptorium è immenso, – e Adso lo paragona a quello di San Gallo – perché occupa tutto lo spazio del secondo piano di un torrione, spazio che invece è suddiviso in due nelle altre torri, ed è illuminato da numerose finestre, con vetrate colorate “come quelle delle chiese”, afferma il narratore, e qui probabilmente si riferisce alle grandi vetrate gotiche delle cattedrali francesi e del settentrione italiano. Anche qui il giovane novizio si lancia in una serie di rimandi allegorici tra terra e cielo, dalla luce delle vetrate abbaziali alla luce celeste, con richiami alle teorie sulla luce di Roberto Grossatesta, che Eco conosceva bene.{26}
Finalmente, attraverso un ossario, e anche questo mi sembra un suggerimento ironico di Eco sulla morte della cultura o sulla cultura dei morti, Adso e Guglielmo penetrano nel cuore dell’abbazia, l’Edificio, disubbidendo al divieto dell’abate.
I nostri eroi, alla fine, riescono ad individuare un libro molto ambìto e il suo geloso custode, che è, come tutti sanno, Jorge da Burgos. Purtroppo, o per fortuna, a seconda della posizione ideologica, il secondo Libro della Poetica di Aristotele, imbevuto di un potente veleno, affinché chi si inumidisse le dita per leggerlo rimanesse fulminato, brucia insieme alla biblioteca, e a tutta l’abbazia nell’incendio finale.
VI
 È singolare notare come altri incendi funestino i romanzi “al passato” di quel periodo, come I dodici abati di Challant, di Laura Mancinelli, uscito nel 1981, qualche mese più tardi del Nome della rosa. Anche quest’ultimo incendio nasce dallo scontro tra due mondi, due diverse convinzioni e visioni della vita: due mondi rappresentati dalla corte di Bianca di Challant e dai monaci venuti al castello per sorvegliare l’effettivo rispetto di un testamento. Anche nel romanzo della Mancinelli si sente forte la semplificazione luce contro tenebre, e con un rovesciamento dell’assiologia evangelica, la luce è il mondo e le tenebre sono monaci che cercano di imporre una visione dell’esistenza basata sull’osservanza acritica e sull’obbedienza cieca. È singolare notare come altri incendi funestino i romanzi “al passato” di quel periodo, come I dodici abati di Challant, di Laura Mancinelli, uscito nel 1981, qualche mese più tardi del Nome della rosa. Anche quest’ultimo incendio nasce dallo scontro tra due mondi, due diverse convinzioni e visioni della vita: due mondi rappresentati dalla corte di Bianca di Challant e dai monaci venuti al castello per sorvegliare l’effettivo rispetto di un testamento. Anche nel romanzo della Mancinelli si sente forte la semplificazione luce contro tenebre, e con un rovesciamento dell’assiologia evangelica, la luce è il mondo e le tenebre sono monaci che cercano di imporre una visione dell’esistenza basata sull’osservanza acritica e sull’obbedienza cieca.
Ambedue gli edifici, l’abbazia di Eco e il castello della Mancinelli sono segno di un rapporto nuovo del narratore con la realtà storica. Questo rapporto è basato non sulla fedeltà ai lacerti storici, che pure qui e là appare, ma sulla convinzione che la storia sia un contraddittorio narrare e che la realtà sia stata piuttosto diversa da quella che leggiamo sui libri. E, come molti hanno sostenuto parlando di Eco, che non vi sia un ordine nella storia.
Nell’abbazia echiana si è compiuto il combattimento tra due opposte concezioni della storia e della cultura, e anche il sacrifico dei semplici, di coloro che testimoniano la loro fede o le loro convinzioni senza altra arma che il loro entusiasmo e il loro coraggio. Il che mi fa pensare anche alla chiusura di un altro romanzo “al passato”, di cinque anni prima, e che non ha avuto lo stesso successo del Nome della rosa, vale a dire Il quinto evangelio di Mario Pomilio: nella sacrestia di una Germania alla fine della seconda guerra mondiale, viene rappresentata una Passione di Cristo. Ogni attore sceglie di impersonare un apostolo, mentre ad uno sconosciuto viene affidata la parte di Gesù. Quando costui inizia ad andare oltre il copione, e a sostenere che l’ubbidienza a Dio comporta anche la denuncia della violenza e della sopraffazione del potere, un ufficiale lo arresta, scoprendogli il capo finora velato: l’uomo mostra una inquietante somiglianza con il Cristo. Nel Quinto evangelio non vi sono abbazie, anche se talvolta esse appaiono sullo sfondo, ma solo una dimessa sacrestia in una città tedesca bombardata dagli alleati, dalla quale parte questa singolare ricerca di un libro che poi si rivelerà essere non altro che la fedeltà al messaggio evangelico. E che molti semplici hanno testimoniato con la vita.
VII
 Ma una abbazia, ancora una volta Farfa, è il cuore di un recente romanzo di uno che Farfa la ha frequentata per molto tempo, come curatore della biblioteca, quella che un tempo era stata considerata una delle meraviglie del mondo medioevale. Si tratta di Gianni D’Andrea e del suo Il tesoro di Farfa che, diciotto anni dopo il Nome della rosa riprende, per l’ennesima volta, lo stratagemma del manoscritto ritrovato, finzione che, come abbiamo visto, proviene da molto lontano. Il manoscritto è del 1849 ma ricorda fatti accaduti ai tempi dell’abate Pietro I di Farfa, precisamente nell’anno 898 della nostra era. Farfa è assediata dai Saraceni da sette anni, riesce a resistere grazie alla presenza dell’acquedotto al suo interno. Via via le descrizioni si dipanano, e sono tra le più accreditate dal punto di vista dell’esattezza storica, la fiera è resa viva dalla precisione con cui sono tratteggiati Ma una abbazia, ancora una volta Farfa, è il cuore di un recente romanzo di uno che Farfa la ha frequentata per molto tempo, come curatore della biblioteca, quella che un tempo era stata considerata una delle meraviglie del mondo medioevale. Si tratta di Gianni D’Andrea e del suo Il tesoro di Farfa che, diciotto anni dopo il Nome della rosa riprende, per l’ennesima volta, lo stratagemma del manoscritto ritrovato, finzione che, come abbiamo visto, proviene da molto lontano. Il manoscritto è del 1849 ma ricorda fatti accaduti ai tempi dell’abate Pietro I di Farfa, precisamente nell’anno 898 della nostra era. Farfa è assediata dai Saraceni da sette anni, riesce a resistere grazie alla presenza dell’acquedotto al suo interno. Via via le descrizioni si dipanano, e sono tra le più accreditate dal punto di vista dell’esattezza storica, la fiera è resa viva dalla precisione con cui sono tratteggiati
L’ampio spazio quadrangolare (che) è delimitato a oriente dal corso della Riana ed è recintato per tre lati da un alto muro di pietra con un’unica cancellata.{27}
E ancora:
Barili di vino, orci d’olio, mastelli di miele e bigonci d’olive salate, forme di cacio, carni affumicate o insaccate, spezie profumate. (…) Grandi griglie di ferro annerite sopra le braci, pesce di fiume e di lago, schidionate di tordi, carni e frattaglie. Cervogia e vino in orci di terracotta.{28}
Al contrario di Il nome della rosa dove le descrizioni sono lacerti incrociati di reali e ideali presenze abbaziali e palaziali che si rincorrono in una scaltra rete di citazioni incrociate, nel Tesoro di Farfa vi è certamente una ricostruzione, per statuto limitata e parziale, ma essa si nutre di studi specialistici tesi alla riscoperta dei luoghi arcaici e alto-medievali dell’abbazia. La descrizione quindi non tenta la strategia della costellazione di trappole semantiche per ingannare più o meno giocosamente il lettore, come in Eco, ma la fedeltà alle ricostruzioni effettuate attraverso le fonti e i ritrovamenti archeologici. La convinzione di alcuni, che abbiamo già visto, che nel Nome della rosa si parli di Farfa o anche di Farfa, potrebbe paradossalmente trovare un punto di appoggio proprio in questo novel di quasi vent’anni dopo, basato sulla fedeltà alle ricostruzioni storiche e sulla lunga frequentazione del luogo:
Sulla massa degli altri edifici si levava la mole bianca della grande basilica, con l’alto frontale listato verticalmente dal gioco d’ombra delle sottili paraste, affiancato dalle cuspidi aguzze dei campanili gemelli, possenti sulle basi quadrate.{29}
Anche perché vi è un particolare che fa pensare a quanto siano complicate le strategie del testo: l’osservazione che le cucine – luogo del corpo – siano strettamente legate alla biblioteca, luogo dello spirito, esattamente come nel grande successo echiano. D’Andrea scrive che
Nello scriptorium, l’unico altro locale riscaldato per tutto il giorno - come in molti monasteri era collocato al di sopra delle cucine e ne sfruttava il calore per mezzo dei condotti interni alle pareti - continuavano a venire alla luce preziosi codici della scrittura tipica farfense, manoscritti che si erano diffusi anche per l’Europa.{30}
Mentre Eco ci informa che
Benché la giornata fosse molto fredda la temperatura nello scriptorium era abbastanza mite. Non a caso era stato disposto sopra le cucine da cui proveniva abbastanza calore, anche perché le canne fumarie dei due forni sottostanti passavano dentro i pilastri che sostenevano le due scale a chiocciola poste nei torrioni occidentale e meridionale.{31}
È il sottile gioco della letteratura e del romanzo cosiddetto storico e che io, ormai il lettore ci si sarà abituato, continuo a chiamare al passato: un brano, quello echiano, che è comune ad un romanzo di diciotto anni dopo che è scritto anche in questo caso da un esperto, ed esperto di quel particolare edificio, in un gioco di rimandi che viene dalla conoscenza delle abbazie, dei testi, delle suggestioni e dei sottili rimandi che soprattutto nel libro di Eco mettono in relazione cibo (la cucina), mondo dei morti (l’ossario che prelude alla biblioteca proibita) e mondo dello spirito (la biblioteca). Carne, senza la quale i libri non potrebbero essere scritti, cultura a contatto diretto con la morte, come a voler anche, la sottolineatura è d’obbligo, dire che la cultura è morta o che la cultura in sé e per sé è il luogo della non-vita, rivelano le inquietanti curvature di una esistenza non così passibile di distinzioni precise come qualcuno potrebbe pensare.
VIII
È evidente che lo sguardo sull’abbazia – e sul tempo altro del passato – è molto mutato nel corso dei secoli, perché è soprattutto uno sguardo interiore, che legge in questo luogo valori personali ed epocali. È una ricostruzione soprattutto ideologica: l’abbazia, da luogo oscuro, teatro di manifestazioni dell’oltre e insieme di azioni umane, diviene spazio delle contraddizioni e delle scelte drammatiche, ma pur sempre luogo deputato della letteratura e dell’arte, perché avvertito, qualsiasi siano le convinzioni dello scrittore, anche come spazio originario della civiltà e della cultura d’occidente.
{1}M. Testi, Il romanzo al passato, Roma, Bulzoni, 1992.
{2}Ho affrontato le dinamiche dello sguardo interiore in letteratura e la visione degli spazi nella scrittura, soprattutto in Federigo Tozzi, in rapporto anche alla pittura coeva, in Altri piani, altre valli, altre montagne, Lecce, Pensa Multimedia, 2007.
{3}A. Radcliffe, L’Italiano, in AA. VV., I grandi romanzi gotici, Roma, Newton Compton, 1993, p. 431.
{4}Ibid.
{5}J. Austen, L’abbazia di Northanger, Roma, Newton, 1994, p. 127.
{6}Ivi, pp. 127-128.
{7}Ivi, p. 131.
{8}Ivi, p. 135.
{9}Ivi, p. 150.
{10}M. G. Lewis, Il monaco, in I grandi romanzi gotici, op. cit., p. 88.
{11}A. Fogazzaro, Il santo, Milano, Mondadori, 1985, p. 115.
{12}Ivi, p. 219.
{13}Ivi, p. 157.
{14}Cfr. W. C. Booth, The rhetoric of Fiction, Chicago-London, University of Chicago Press, 1961.
{15}A. Fogazzaro, Il Santo, op. cit., pp. 103-104.
{16}I. Giordani, La città murata. Storia del tempo d’Ildebrando, Roma, Anonima Veritas Editrice, 1936, pp. 47-48.
{17}Ibid.
{18}Ivi, p. 83.
{19}U. Eco, Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 1984, p. 29.
{20}Ivi, pp. 29-30.
{21}Ivi, pp. 48.
{22}Ivi, pp. 51.
{23}Farfa la dotta, in “Luoghi dell’infinito”, aprile 2002, pp. 56-65.
{24}Ivi, pp. 58.
{25}Dubbi sull’attuale attribuzione all’artista fiammingo Hendrick van den Broeck sono stati sollevati da Giovanna Sapori nel suo intervento Un apice della pittura fiamminga in Italia, in AA. VV., Spazi della preghiera, spazi della bellezza. Il complesso abbaziale di Santa Maria di Farfa, Roma, Palombi, 2015, pp. 163-177.
{26}Cfr. U. Eco, Arte e bellezza nell’estetica medievale, Milano, Bompiani, 1994.
{27}Gianni D’Andrea, Il tesoro di Farfa, Roma, Media Print, 1998, p. 16.
{28}Ibid.
{29}Ivi, p. 22.
{30}Ivi, p. 33.
{31}U. Eco, Il nome della rosa, cit, p. 134.
Questo intervento è tratto dalla relazione preparata da Marco Testi per un convegno sulle abbazie che si svolgerà prossimamente a Farfa [NdR].
testi.marco@alice.it
|