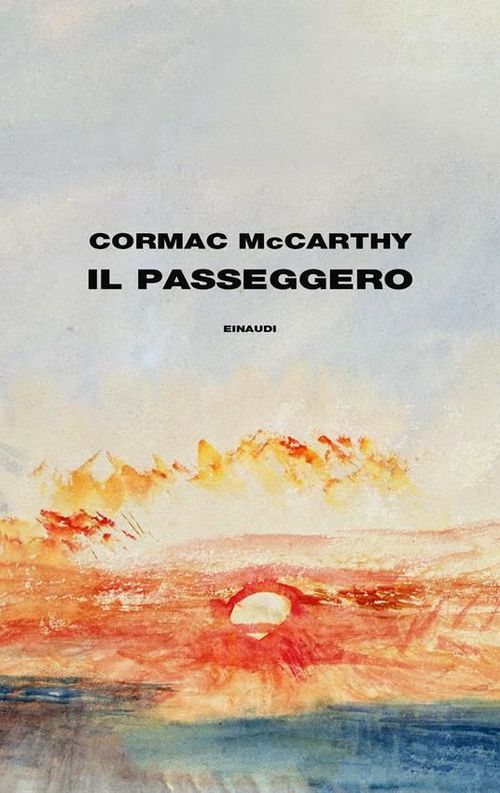 Il dittico finale di Cormac McCarthy, scomparso il 13 giugno a 90 anni, Il passeggero e Stella Maris, è qualcosa di più di una nuova tappa di quello che in parte era stato narrato in precedenti racconti, come La strada: lo sguardo nuovo su un mondo antico, la prospettiva arcaica e distopica che non ammetterebbe speranza, il deserto imprescindibile se si vuole pagare conti non personali, o per lo meno apparentemente non tali in cerca di qualcosa che giustifichi il sospetto di insensatezza della vita sono parte del passaggio umano sulla terra. E qui, come vedremo, radici religiose latu sensu manifestano la loro profonda persistenza. Il dittico finale di Cormac McCarthy, scomparso il 13 giugno a 90 anni, Il passeggero e Stella Maris, è qualcosa di più di una nuova tappa di quello che in parte era stato narrato in precedenti racconti, come La strada: lo sguardo nuovo su un mondo antico, la prospettiva arcaica e distopica che non ammetterebbe speranza, il deserto imprescindibile se si vuole pagare conti non personali, o per lo meno apparentemente non tali in cerca di qualcosa che giustifichi il sospetto di insensatezza della vita sono parte del passaggio umano sulla terra. E qui, come vedremo, radici religiose latu sensu manifestano la loro profonda persistenza.
Stella Maris (edito in Italia da Einaudi), uscito in questi giorni (ne parleremo sul prossimo numero di “Fili d’Aquilone”) è in realtà il prequel della storia – ma sarebbe il caso di scrivere le storie – racchiusa in Il passeggero, che sembrerebbe, ai blocchi di partenza della lettura, un’indagine sulla scomparsa di un membro di un piccolo jet precipitato in mare non lontano dalla costa del Mississippi. Tutti gli altri cadaveri sono al loro macabro posto all’interno di un velivolo che sembra intatto, ma a qualcuno questo sembra molto, e pericolosamente strano.
Il protagonista, ma sarebbe il caso di dire il co-protagonista, del racconto, Bobby Western, un sommozzatore specializzato in recuperi sottomarini, ma anche fisico, e pilota d’auto da corsa, che scopre l’ordine apparente di una cabina mortuaria, con tutti i cadaveri scarnificati al loro posto, tranne uno che avrebbe dovuto essere lì, diviene l’agnello sacrificale di un enigma mai svelato, colui che cela a sua insaputa il segreto di quella assenza, che avrebbe – mai come in questo caso il condizionale è necessario – risparmiato una vita ma che ha in realtà innescato indagini governative e una sorta di capillare persecuzione investigativa. Che si sovrappone alle profondità inaccessibili, finanche alla scrittura, di una storia familiare in cui l’amore devastante e mai consumato tra fratello e sorella tocca per qualche attimo le domande solitarie di chi non crede alla vita, al suo senso e scopo. Senza mai definire un percorso a direzione unica di rifiuto e rimozione di qualsiasi possibilità di sentire la presenza della luce nel bel mezzo della notte dell’anima.
Storie di malandati bohémien metropolitani al fioco neon di un Hopper ancora più spettrale e malinconico, antichi cavalieri che si ritrovano sette secoli dopo a sillabare frammenti di cortesie verbali tra un caffè quasi sempre offerto da altri e la ricerca di qualche spicciolo per passare la nottata, di travestiti e di possibili amori scavalcati da un ricordo troppo devastante per essere sopportato e raccontato con la speranza di una distanza terapeutica secondo i canoni di una cura che riaggallerà nel recupero del prima in Stella Maris. Sintagma questo che rimanda alla devozione mariana, che a sua volta alimenta il nominalismo clinico delle strutture gestite da personale religioso. Ma non è solo una questione nominalistica.
L’abisso del perché e dello sguardo sulla risposta nei luoghi che non ne rispettano il canone vulgato – spiagge solitarie, caseggiati in abbandono, capanne provvisorie, jeep, macchine da corsa, bar qualsiasi in cui l’evento atteso e innominato potrebbe offrire un segno – sono l’altra faccia di Il passeggero.
 Certo, McCarthy non è il primo e non sarà l’ultimo ad affrontare il tema dell’amore all’interno della famiglia, dal John Ford di Peccato che sia una sgualdrina allo Scott Fitzgerald di Tenera è la notte, e con quest’ultimo in comune la dimensione della schizofrenia come frutto incestuoso e insieme difesa da una razionalità desolata e priva di amore. Anche se in Il passeggero l’amore tra fratello e sorella non diviene mai fatto concreto: è semmai rimpianto, assenza, desiderio, fuga e sogno irrealizzabile nel qui e nell’ora. Certo, McCarthy non è il primo e non sarà l’ultimo ad affrontare il tema dell’amore all’interno della famiglia, dal John Ford di Peccato che sia una sgualdrina allo Scott Fitzgerald di Tenera è la notte, e con quest’ultimo in comune la dimensione della schizofrenia come frutto incestuoso e insieme difesa da una razionalità desolata e priva di amore. Anche se in Il passeggero l’amore tra fratello e sorella non diviene mai fatto concreto: è semmai rimpianto, assenza, desiderio, fuga e sogno irrealizzabile nel qui e nell’ora.
Il desiderio di Alicia, la sorella di Bobby, di “non essere mai stata qui fin dall’inizio” attraversa fantasmi di senso legati non solo e non tanto ad un credo – che pure è una sotterranea presenza – ma a barlumi di ricordi ancestrali di qualcosa che è già stato nostro. La convinzione che “il mondo è un posto ingannevole”, che la bellezza non solo non garantisce quel senso ma anzi “fa promesse che non può mantenere”, la visione del pianto dei neonati come anticipo di un conto salato di insensatezza, la predisposizione verso la fisica quantistica e probabilistica di lui (con riferimenti precisi ed estesi a Oppenheimer, prima della realizzazione del film di Nolan), la matematica ad alti moduli e alla musica di lei non rappresentano garanzie, anzi: sono movimenti eccessivi e precoci di un sé che non dovrebbe sondare ciò che non può né capire in fondo né avvicinare senza rimanere ustionati.
L’ombra di un Giardino Perduto che manda segni di forse e chissà è un sisma silente che ogni tanto riaffiora con inquieti indizi di presenza in profondità. La vera natura delle tenebre, dei sogni, la necessità non desiderata di cercare nelle tenebre senza la certezza che vi sia una fine del viaggio sono segni di una continuità con una letteratura che fa della disperazione e della presenza reale del male su questa terra la necessità per la strada del bene: Calderon de la Barca, Shakespeare, Marlowe, Conrad, Flannery O’ Connor, Melville, Chesterton, la letteratura distopica sono ben presenti non come razionale scelta di fonti, ma come parentela attraverso le generazioni e le mode che lasceranno sempre il tempo che trovano.
Il passeggero è un delirio – e vi fanno ingresso sprezzanti e osceni folletti, ma paradossalmente unici compagni in grado di condividere gli incubi di Alicia, tra i quali emerge come parossistico capo il Kid – molto vicino al racconto senza apparente senso dell’idiota dello Shakespeare di Macbeth, pieno di rumori e di furori che non significa nulla. Solo che quel nulla appare qui un mistero sacro, una stazione di una liturgia (s)conosciuta, il frammento di un antico disegno che va oltre il tentativo e scavalca la nostra ybris millenaria.
Cormac McCarthy, Il passeggero, Einaudi 2023, 385 pagine, 21 euro.
testimarco14@gmail.com
|