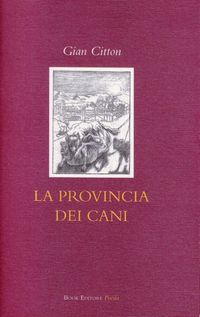 La poesia Gian Citton non è collocabile – e per fortuna, vista la manìa di etichettare in correnti esperienze che non possono essere costrette in categorie che ne uccidono la ricchezza – in un alveo poetico preciso. E si cadrebbe in errore se si volesse prendere spunto da suo ricorrere al dialetto veneto, è nato a Feltre, vicino Belluno, per farne uno scrittore regionale o regionalistico. La poesia Gian Citton non è collocabile – e per fortuna, vista la manìa di etichettare in correnti esperienze che non possono essere costrette in categorie che ne uccidono la ricchezza – in un alveo poetico preciso. E si cadrebbe in errore se si volesse prendere spunto da suo ricorrere al dialetto veneto, è nato a Feltre, vicino Belluno, per farne uno scrittore regionale o regionalistico.
Citton raggiunge zone della sensibilità umana piuttosto infrequentate e nello stesso tempo è capace di stare dentro le cose, quelle di uso comune, la vita popolare, la campagna, il paese, la provincia, e non solo queste. Semmai l’uso della coinè locale offre una maggiore capacità di penetrare nelle radici del dolore, della comunità, del tempo che passa, di tutto ciò che fa la vita insieme ad altri.
Vi è sicuramente, in questa sua recente raccolta La provincia dei cani (Book Editore, 2015), che raccoglie poesie scritte tra il 1999 e il 2015, una vena di fatalismo e di disilluso realismo. Ma non è un compianto individuale, isolato e in qualche modo arroccato su una pronuncia leopardiana di fine delle illusioni. Sempre che Leopardi, il che non è vero, abbia messo la parola fine sulla utilità “irrazionale” delle illusioni stesse. Citton entra dentro la sostanza delle cose, che sono fatte di dolore e di piacere, di speranza e di inquietudine, di fame e di benessere, di paese e di città senza declamare, anzi, senza quasi rivendicare ad una sua propria voce lo sguardo sulla vita. Sembra quasi che quella medesima vita si imponga allo sguardo, se ne serva semplicemente come elemento di espressione di se stessa.
Le parole, come ho già avuto occasione di scrivere, in Citton emergono nella loro necessità, fanno emergere “le profondità talvolta insidiate dalla banalità delle parole stesse”. La provincia dei cani si apre con una sorta di poema assai breve sul destino, di una donna.
L’Adelina ricorda?
quell’umido dell’ottomana nell’umido
della cucina pianoterra (senza fonde
la casa – dopo il Belgio – tirata su
a fianco della stalla)?
Sassi e mattoni spacca-schiena e mena
malta par ligar i muri tut in sparagno;
ma poi quella cucina pianterrena
è sempre fredda, muffa e sgrisoloni.
Un destino che incrocia cronologicamente un altro destino, la data del fatidico Sessantotto: “Il Sessantotto di Adelina” è qualcosa di assai raro nel nostro panorama poetico d’oggi. L’eroina è una donna che ha vissuto la sua vita nella semplicità, nelle speranze, nel dolore, tranquillamente, senza fare chiasso e senza però sparire nelle latebre del silenzio e del nulla. La domanda se “L’Adelina ricorda?” è in realtà da capovolgere: “qualcuno ricorda ancora l’Adelina?”. È in questo ricordare che si nasconde il vero senso del tutto? Grazie a questa poesia il lettore può finalmente avere una risposta di speranza. Sì, è possibile il ricordo che salva. Anche per la povera gente, anche per chi non ha apparentemente lasciato segno nella storia. Anzi, sembra dire Citton, forse proprio per questo.
Così (che più non può, ma se potesse!)
ricorda l’Adelina il sessantotto suo
– bruciato nella febbre.
Emerge una singolarissima e radicale pietas, immersa in quella vita e in quello sguardo apparentemente inesorabile ma in realtà carico di commozione: “Che è l’umido della cucina – e sempre il fradicio/ dell’ottomana – e sempre i chicchi/ di valium che ne ha perso il conto/ a sgretolarli a uno a uno i giorni/ sulla sua faccia a cinquantotto anni”. Il sessantotto di Adelina è stato “bruciato nella febbre”. Che c’è di più epico in questa vita resa universale grazie alla poesia che l’ha salvata dal drago della dimenticanza?
In realtà Citton sorprende in tutta la raccolta per la sua naturale capacità di penetrare nel profondo senza parere, con un colloquiare amabile, per nulla costruito o teatrale, tutto teso a intuire nel saluto, nella chiacchierata, nello sguardo sulle cose più umili, i segni di un senso. Che non può essere consegnato al nulla. E la comunità tra gli uomini è uno di questi segni. È infatti assai forte anche se mai declamato o enunciato teoricamente – il che ammazzerebbe la poesia – la ricerca dell’altro, la lotta contro la solitudine e la rassegnazione fatale, quella al non senso dell’esistenza. Anche quando “dopo l’ultima opera di misericordia”, come recita il titolo di una lirica, si contempla con dolore e con affetto l’immagine di chi, pur non essendoci più, ci ha lasciato qualcosa di tangibile: la sua presenza, un sorriso, un caffè preso assieme, due chiacchiere in allegria. Questo, sembra dire Citton conta, e sempre.
Ognuno
di loro addita a chi rimane
di là oltre il muro che li apparta,
la linfa della vita che resiste.
Gian Citton, La provincia dei cani, Book Editore, 2015, pagg. 96, euro 15.
 Gian Citton Gian Citton
è nato nel 1938 a Feltre, dove vive. Dopo la laurea in Lettere Moderne si è dedicato all’insegnamento nelle Scuole Medie e Superiori e con incarichi presso l’Università di Trento.
Le sue prime poesie sono uscite fra il 1956 e il 1961 in antologie e riviste. Dopo un periodo di silenzio ha ripreso a scrivere intorno al 1975/76 pubblicando la raccolta Stanze (1976 -1986), In Forma Chiusa (2000, con una nota di Alberto Bertoni), Le Carte del Caribe (2003, Premio Senigallia), Indovinare il mare (2004, introduzione di Giorgio Bàrberi Squarotti), Tomàdego méo (2005, in dialetto friulano), Devozioni musicali per vecchi fan (2008), T’un ingano de sol (2010, in dialetto feltrino) e La provincia dei cani (2015).
testi.marco@alice.it
|