rivista d'immagini, idee e Poesia

luglio/settembre 2007
Altre terre
| FILI D'AQUILONE rivista d'immagini, idee e Poesia |
 |
Numero 7 luglio/settembre 2007 Altre terre |
|
ANGELO MORINO di Alessio Brandolini |
|
Nel giugno 1959 il professore napoletano Ernesto De Martino compie un viaggio di studio, un'inchiesta antropologica di venti giorni nel Salento, regione della Puglia protesa ad arco tra l'Adriatico e lo Ionio. Un pezzo di Sud primitivo che appare come imprigionato tra due mari diversi, luogo del silenzio e della desolazione. Con lui ci sono un gruppo di studiosi di orientamento marxista, un giornalista e un fotografo.
Il protagonista del nuovo romanzo di Angelo Morino, Rosso taranta (Sellerio, 2006), legge il libro di De Martino, ne rimane colpito, affascinato e decide di ripercorrere quel viaggio.
Il romanzo segue le orme della spedizione demartiniana e ha come un tempo doppio: la narrazione precisa d'un occhio quasi neutro che registra tutto quello che vede del secondo viaggio s'intreccia a quella degli studiosi, ne ripercorre le tappe, vengono descritte le foto che il primo libro contiene. Sono le immagini delle tarantate, ovvero delle donne che si dicono morse da una tarantola: durante la spedizione furono identificati 37 casi di tarantismo, di cui solo cinque uomini (e poco convincenti).
Il rito antichissimo è una specie di cura collettiva, gestita dalla comunità locale e parentale, e consiste in una tecnica musicale di catarsi. Per questo è meglio parlare di tarantismo che di tarantolismo, che richiama la lycosa tarentula degli zoologi e lascia intendere il fondamento realistico del morso.
Il libro di De Martino chiarisce che il morso della taranta non è un elemento della realtà, ma "un simbolo che ha preso corpo fra traumi, frustrazioni, conflitti (...), la taranta diventa il simbolo di un cattivo passato, lì dove qualcosa ha subito un blocco".
L'intrecciarsi del viaggio del 2001 a quello della spedizione del 1959 crea una specie di ancoraggio nel tempo ed è come se ogni cosa fosse vista due volte, con occhi diversi eppure non del tutto dissimili, creando un effetto di rifrazione che illumina la scrittura, i paesaggi, i fatti, persino le foto del primo libro narrate (descritte e come rifotografate) nel romanzo.
Rosso taranta è un romanzo a sfondo autobiografico (Angelo Morino è, come il protagonista di questa storia, un professore universitario e vive a Torino e che ama il sud), un diario di viaggio dove il narrare preciso e distaccato, di stampo illuministico (non viene usata mai la prima persona singolare) corrisponde a una precisa scelta stilistica per tenere sotto controllo un dolore lacerante e profondo, legato, probabilmente, al giovane compagno di viaggio che qui si vede poco, e a un corpo sofferente descritto attraverso una foto. I due personaggi della storia che viaggiano assieme sono stati quasi del tutto cancellati (così come non viene mai fatto il nome di De Martino) perché, scrive l'autore in un Post scriptum, "occorreva scrivere mettendosi a tacere, aprirsi all'interno e sperdersi lì dentro". Un viaggio intenso e inquieto, pieno di colori (e predomina il rosso), d'odori, di suoni e balli sfrenati, inquietanti e, insieme, un viaggio a ritroso nel tempo, nella storia del nostro paese e nelle zone (nei pozzi) del cuore e della mente dell'uomo. In questo senso, il nuovo e affascinante lavoro di Angelo Marino ha parecchie affinità con il romanzo precedente In viaggio con Junior (2002), ma qui il protagonista non insegue l'amore ma, forse, l'origine misteriosa della passione che ci riguarda tutti, o il male (il rimorso) che viene dal vivere una vita lontana dai propri desideri. Angelo Morino, Rosso taranta, Sellerio editore, Collana "La memoria", Palermo 2006, pagg. 191, euro 10 |
Da Rosso taranta
(pag. 48-50)
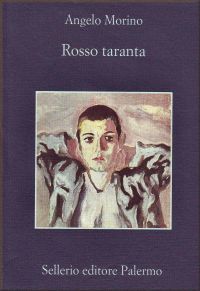
|
Adesso, è l'ultimo tratto prima della meta: Galatina, a neppure trenta chilometri di qui. Ieri, consultando gli orari degli autobus, si è visto che i collegamenti non mancano. Una corsa ogni ora, dalle sei del mattino fino alle otto di sera. A mezzogiorno non c'è molta gente in partenza. In mezzo agli altri viaggiatori, un gruppo di albanesi, simili ai due visti all'Ostiense. Qui sono cinque, senza bagagli, a mani e tasche vuote, dai venti ai trent'anni. Malgrado l'ora avanzata, facile che siano comunque avviati verso qualche lavoro nei campi. Si siedono in fondo all'autobus, sempre parlando e scherzando, familiarizzati con i luoghi intorno. Le terre da cui vengono non sono lontane: soltanto un canale di mare le divide da queste. Una lunga storia di spostamenti e di migrazioni, quella che li precede. Sì, fin da quando si chiamavano messapi e venivano da dove oggi ci sono l'Albania e il Montenegro. Ma, in questi anni, non sono qui per imporsi e fondare città. Nel mazzo dei tarocchi, la loro carta è quella del Bagatto. L'uomo senza età, che attraversa il mondo con in involto appeso a un bastone sopra la spalla. Sempre con un piede sollevato nel passo imminente, come ballando su un ritmo che solo le sue orecchie riescono a cogliere. Sempre pronto ad andare oltre, a spingersi altrove, a cambiare direzione. Folle e vagabondo, povero fra i poveri della terra, incurante del vuoto che gli si può spalancare sotto i piedi.
La periferia di Lecce è abbastanza estesa. Centri commerciali, fast food, insegne dai colori accesi: tutto appoggiato lì come per caso. Basterebbe un colpo di vento e ogni cosa verrebbe spazzata via, mettendo a nudo un altro paesaggio, più antico. Automobili, treni e autobus permettono di vederlo sfilare e mutare, il paesaggio. Niente che rimanga chiuso come fra due parentesi, dall'aeroporto di partenza a quello di arrivo. Spostandosi attaccati al suolo, il mondo conserva la sua ampiezza e le sue distanze. I cambiamenti si preparano e diventano più comprensibili. Evitate le accelerazioni di tempo troppo brusche. Rispettati i passaggi graduali, in scorrimento progressivo. Oltre la periferia di Lecce ci sono ancora appezzamenti coltivati a tabacco, comunque un residuo rispetto a quelli di una volta. Le campagne antifumo ne hanno assecondato la conversione in colture di girasoli. Così gialli, con quel disco scuro e granuloso in mezzo, li si direbbe fatti di carta crespa, pronti per una recita interpreta da bambini. |
CINQUE DOMANDE AD ANGELO MORINO
|
Nel tuo precedente lavoro, In viaggio con Junior dagli Stati Uniti ci si spostava nel Sud dell'Italia, precisamente a Matera. Qui, in Rosso Taranta il romanzo è ambientato ancora più a Sud, nel Salento. Una terra strana, una penisola che sembra un'isola? Una terra ancora fortemente legata al passato? Sono un uomo del Nord. Nato fra le montagne, in Val di Susa, a 700 m. di altitudine sul livello del mare. Il sogno degli uomini del Nord è questo: andare verso il Sud, verso il sole, verso il mare. Credo che associamo il Sud all'idea di una vita in maggiore libertà, sotto ogni punto di vista. Un'idea romantica, probabilmente, da viaggiatore che varca le Alpi e scende verso le belle terre del passato, dove vivere è più facile. Ma, quanto a me, c'è anche qualcos'altro, legato alla mia infanzia e agli anni a cavallo fra i '50 e i '60 del secolo appena trascorso. Da piccolo, lì dove abitavo, il mio Sud era la gente che ne proveniva. La gente che era migrata al Nord. I terroni, come si diceva allora. Erano diversi, parlavano in modo diverso, mangiavano cose diverse. Consideravano la carne un cibo per i ricchi. Si nutrivano di pasta e di pomodori. C'era la signora Alì che non voleva che i suoi figli giocassero con me. Diceva che avevo gli occhi celesti di una capra morta e che portavo male. C'era persino una bambina che raccontava come, al suo paese, avesse vissuto nelle grotte, in una città tutta fatta di grotte. Quasi un pezzo di fiaba, qualcosa che non trovava posto nella mia realtà. È stato anni e anni dopo, quando ho visto Matera, che quella bambina mi è tornata in mente. Forse, lei veniva proprio da Matera, dai Sassi. In una prima versione di In viaggio con Junior, ne parlavo, la rievocavo. La bambina delle grotte, mal vista nel cortile dove noi bambini giocavamo, perché aveva i pidocchi.
Nel "Post scriptum" che chiude il libro spieghi l'origine del romanzo, gli appunti presi nel 2001 "quasi si fosse voluto giocare a una ricerca antropologica sul campo". Una cosa che mi ha colpito molto nel romanzo è proprio l'ancoraggio a una terra ben delineata, la Penisola Salentina. In effetti una ricerca antropologica qui c'è ed è anche doppia: si parla del tempo presente di questo lembo di terra circondato dal mare e di quello passato, visto attraverso il famoso saggio di De Martino, La terra del rimorso. Io non sono un antropologo, però sono andato nel Salento obbedendo a uno stimolo venuto dalla lettura del libro di De Martino. Che antropologo lo era, eccome. In quel periodo, mi era pure accaduto di rileggere Tristi tropici, di Lévi-Strauss. Rispetto a De Martino, rispetto all'antropologia, il mio può essere stato solo un gioco. Se qualcosa volevo fare, scrivendo, era fare letteratura e non antropologia. Mi hanno detto, però, che le due cose non sono così lontane l'una dall'altra. Non saprei. Io non ci ho mai pensato. Una mia amica, Elsa Guggino, che di antropologia ne sa, mi ha sostenuto molto. In qualche caso, ha persino capito Rosso taranta meglio di me, me l'ha spiegato.
Nel romanzo viene tutto filtrato attraverso lo sguardo di un protagonista neutro, ma non neutrale. Non usi mai la prima persona, c'è come uno sguardo scientifico (di stampo illuminista) sulle cose e, sopratutto sulle persone. Come mai questa scelta stilistica? Mi sono sempre piaciuti quegli scrittori che lavorano mettendosi una regola a cui attenersi. Mi dà l'idea che, così, scrivere sia una forma di disciplina. Non credo in un'ispirazione cieca, che irrompe e travolge. Ho tutta un'altra idea, più vincolata, per l'appunto, al lavoro. Metti Georges Perec, che scrive un romanzo proponendosi di non usare mai la vocale e. Un romanzo intero, dalla prima all'ultima frase, senza che compaia una sola e. In questi casi, occorre accentrare l'attenzione su quello che si scrive, al massimo. Occorre tenersi in uno stato di all'erta continua. Cercare altre soluzioni rispetto a quelle più ovvie. Mai arrendersi alla prima frase che viene in mente. Ho fatto come loro. La regola che mi sono posto è stata: scrivere una storia in prima persona senza mai usare segni linguistici relativi alla prima persona.
Il protagonista è un professore di Torino, e nel "Post scriptum" spieghi l'origine del romanzo, collegandola a tue esperienze personali. Però poi i dati biografici vengono come messi da parte, occultati. Nel viaggio il protagonista sembra essere solo, poi si comprende che c'è un'altra persona. Probabilmente amata, di sicuro legata alla Terra che qui si descrive. Davvero "occorre scrivere mettendosi a tacere"? Un'altra persona che partecipa al viaggio, c'è. C'è stata nella realtà e c'è nel libro. Amata o meno, questo non ha molta importanza. Compare persino il suo ritratto. È uno di quelli dei diversi ragazzi che vengono registrati dallo sguardo. Ma non è una persona in qualche modo legata alla zona descritta. Anche questa persona è di passaggio. Non sta tornando nel Salento, vi passa attraverso. Il suo non è un ritorno alle radici. Accompagna il protagonista, di cui, insieme al libro di De Martino, ha determinato il viaggio. È qualcuno che viene sentito dalla parte delle tarantate e che, volgendosi verso le tarantate e la loro storia, si vuole capire, per non soccombere all'irrazionalità. Un brutto giorno, la taranta l'ha morso e, da allora, tutto è cambiato in peggio per lui. Una cosa difficile da accettare, un'ingiustizia che fa male, a testimonianza dell'assenza di un dio.
Sono molti i colori (e gli odori) di questo romanzo. Basti pensare al giallo dei girasoli del brano riportato qui sopra. Ma c'è un colore che predomina sugli altri e che caratterizza persino le magliette dei ragazzi, ed è il rosso. Collegato a quella terra? alle tarantate? o anche ai moti del cuore (così discreti e sofferti) del protagonista? Per questo poi il titolo del romanzo, quel "rosso" taranta? Nel giugno del 2001, quando sono andato nel Salento, il rosso era un colore che i ragazzi del posto - più i ragazzi che le ragazze - portavano tantissimo. Un caso, un colore imposto dalla moda e dalle ditte di abbigliamento. Ovunque si guardasse, saltava fuori qualcuno in t-shirt o canottiera rossa. Durante la fiera di Galatina, mi è venuto da pensarlo. In mezzo alla folla, c'era questo rosso che balenava di continuo. Un rosso legato a quei giorni, a quella celebrazione: rosso taranta, mi sono detto fra me e me, un pomeriggio. L'ho anche scritto subito su un taccuino che tenevo in tasca. E l'ho pensato, in quello stesso momento: sarebbe un bel titolo per un libro.
|
 ANGELO MORINO
ANGELO MORINO
È nato a Torino, dove tutt'ora vive. È titolare della cattedra di Lingue e Letterature Ispanoamericane all'università di Torino, traduttore, saggista e romanziere. Con L'editore Sellerio di Palermo ha pubblicato La donna marina (1984), Cose d'America (1995), Nome e cognome di donna. Assunta Spina (1996), Marta Riquelme ovvero Non toccare la donna bianca (1996), Il cinese e Marguerite (1997), Il libro di cucina di Juana Inés de la Cruz (1999), In viaggio con Junior (2002) e Rosso taranta (2006). |
|
|