|
Solo a colui che sa rinchiudere l’universo
nell’universo stesso non può sfuggire niente.
Perché egli coglie
la realtà fondamentale
delle cose durevoli.
(Zhuangzi, VI)
A più di un anno dalla scomparsa del poeta Eugenio Montejo (Caracas, 1938 – Valencia, 2008), una delle voci maggiori nel panorama letterario venezuelano e ispanoamericano attuale, è necessario tornare ai suoi “paesaggi” cantanti e decifrarne il misterioso “terrestre” alfabeto, perché, come pochi contemporanei, egli ha saputo percepire e cantare dall’interno del nostro mondo urbano il lento “soffio” divino che unisce ogni singola vita all’armonia universale. Leggendo l’opera di questo Orfeo del tropico, l’abitante della città assordante e geometrica riscopre una prospettiva più naturale e armoniosa, capace di coniugare il punto di vista dell’uomo occidentale urbano, la cultura europea e cristiana, con uno sguardo altro, più arcaico forse, spesso definito “taoista”, che si riempie di tutto ciò che esiste e coglie l’assoluto in ogni minimo frammento di realtà, o – per dirlo con le parole del poeta – la voce silenziosa degli «dèi profondi» e «pratici» che dice il mondo e lo sostiene.
Eugenio Montejo ha scavato nella parola umana per tirar fuori dal groviglio astratto della lingua frammenti di pura vita, intuizioni di materia. La sua opera è la ricerca della parola terrestre, circolare, fluida, che sia cosa fra le cose, paesaggio, suono percepibile al tatto. Leggiamo in El cuaderno de Blas Coll (1981): «La costruzione di ogni frase deve riprodurre, per quanto possibile, la forma di gravitazione degli astri. Il soggetto deve ruotare come il sole».1 La vera poesia per lui nasce dalla vita come il pane e il poeta è un artigiano che faticosamente, con lenta solenne dedizione lavora la materia terrestre. «Non c’era più forma nella parola che nella vita»,2 scrive in Epistola senza forma.
Montejo ha cantato la terra rintracciandovi la fonte della poesia. Dalla prospettiva dell’uomo di città, dalla Caracas che fagocita la lenta vita dei campi, cancella i volti e soffoca le voci, ha saputo tradurre in limpidi versi il legame primordiale tra l’uomo e la sua «calma», «serenissima» Madre:
Tocco la terra con le mie mani
questa terra sacra e così antica
dove i miei genitori mi portarono.
[...] Sono colui che va sognando tra le cose,
la luce di un sogno che s’incarna
e terra viva, parola della terra,
un infimo frammento del suo specchio,
mai ci siamo separati.3
Francisco Rivera inscrive la sua opera nella tradizione della poesia cosmica nietzschiana, perché quando scrive non si limita ad abbracciare la dimensione visibile del nostro mondo terrestre, ma protende i sensi e la coscienza all’idea smisurata dell’intero esistente. La terra di Montejo è la natura tutta, l’universo incommensurabile in cui tutto è correlato, in cui ogni fibra, ogni essenza, è parte di un’intricata rete di organiche corrispondenze e in cui il corpo umano è un microcosmo che ripete in sé le leggi del tempo e della galassia («e il sangue percorre il suo profondo universo / più sacro di tutti gli astri»4). Gli abitanti di questo smisurato organismo – animali, vegetali e minerali – vivono in un dialogo perpetuo, solidale, in cui materia, suoni, impulsi e pensieri circolano fluidi fra i corpi e le menti in una specie di “osmosi”. «Sentire. La terra gira perché sente / lo spazio stellato. E il mare e il mondo / e il minuscolo stelo d’erba»,5 anche il tordo nero “sente” il pensiero di un albero, lo filtra come un fluido, se ne lascia possedere: «Oggi, ad esempio, mentre ascoltavo il grido / di un tordo nero, di ritorno verso casa, / grido ultimo di chi non attende un’altra estate, / ho capito che nella sua voce parlava un albero, / uno dei tanti».6
La traiettoria della poesia montejiana è discendente e costantemente protesa all’origine dell’essere e della parola poetica. Nella concentrazione creativa, come in un antico rituale, il poeta sprofonda nella materia terreste incarnando uno stato di purezza tellurica traducibile solo con un neologismo appena emerso dal silenzio dell’immaginazione: la terredad, ovvero l’energia circolare che tutto permea e che lo prende tra infiniti giri aprendogli lo spirito a un sentimento di pietà universale, apparentemente opposto e irriducibile al senso di scissione dalla natura e di spaesamento che oggi abita l’uomo urbano. Tra questi due poli è tesa la poesia di Montejo, tra una visione onnicomprensiva e totalizzante e un doloroso individualismo malinconico, tra la consapevolezza che «la vita vale più della vita»7 e il drammatico attaccamento alla propria individualità, effimero, mutilato segmento sul giro continuo del cosmo.
Al di sotto dell’apparente semplicità del dettato poetico palpita un’intricata complessità che si nutre di tradizioni diverse e distanti: della cultura occidentale e cristiana, della letteratura europea, spagnola e ispanoamericana, della cosmologia amerindiana, africana, e della cultura orientale, soprattutto taoista. Visioni del mondo che insieme, accanto agli stimoli del paesaggio venezuelano, compongono una poesia universale e al contempo originalissima, che traduce l’immagine primordiale col linguaggio dell’una o dell’altra tradizione. Dietro all’immediatezza di versi che dialogano con la parte più profonda del pensiero grazie a un linguaggio spontaneo, lirico, fluido come l’acqua, si aggroviglia insomma una prospettiva vastissima, che riflette sulla scissione tra l’uomo e la natura generatrice, sull’inevitabile ritorno alla Terra - Madre, sulla fluidità dello spazio e del tempo, sulla morte come cambiamento di stato e sul valore della poesia.
Il poeta della terredad è l’uomo contemporaneo e urbano che si dibatte tra la propria solitudine cosmica e il desiderio di ritrovare il legame antico e vegetale col trascendente; l’uomo della città che soffre perché le sue radici languono assetate fra strati di secco cemento, ma che, nonostante tutto, riesce ancora a sentire la continuità organica tra il suo corpo e il mondo, come un albero, un passero o l’immobile pietra («Credo nelle nuvole, nelle loro pagine / nitidamente scritte / e negli alberi, soprattutto d’autunno. / (Talvolta mi sembra d’essere un albero)»8). Francisco Rivera lo definisce «poeta di tensioni in cerca di equilibrio»,9 un poeta, aggiungo, costantemente in bilico tra due atteggiamenti dello spirito: da una parte il razionalismo analitico dell’uomo occidentale e moderno che tragicamente constata la propria relatività e l’intrascendenza della vicenda umana, dall’altra la sensibilità arcaica, animista, primordiale di chi percepisce l’assoluto in ogni cosa. Su questo dualismo si costruisce, fra tante, la poesia Settembre:
10
La «lenta luce del tropico», che accecando la vista e la ragione rivela la sacra unità della terra e dei contrari («Erano corpi neri in un’aria bianca / e bianchi in un’aria nera, / musicalmente la luce li univa. / Il tropico fu sempre un altro pianeta»11), insieme all’influenza delle cosmologie amerindiane, della spiritualità africana e delle letture “taoiste”, fa sì che sulla prospettiva “lineare” e geometrica dell’uomo urbano prevalga il pensiero profondo, “circolare”, che soggiace alla coscienza e la precede. Quel pensare che il maestro Blas Coll, eteronimo di Eugenio Montejo, descrive con queste parole:
[…] lo stesso del pianeta che ci porta e, in generale, della galassia di cui siamo una minuscola particella. Procede invariabilmente, come le lancette dell’orologio, da sinistra a destra; perciò è destrorso. […] finché non raggiungeremo le spirali inverse che in noi giacciono occulte, non potremo portare alla luce certe idee, che per la loro bellezza enigmatica sorprendono come il mitico quaderno di un narvalo. 12
La tradizione taoista: lo spontaneo fluire della natura
Fra le tradizioni alla base della poetica montejiana quella taoista è probabilmente la meno studiata, anche se spesso citata dai critici. In effetti è quasi inevitabile farvi riferimento, giacché indizi su un dialogo “letterario” fra Montejo e il mondo cinese si ritrovano numerosi sia nella sua opera sia in alcune interviste in cui riflette sulle radici della propria scrittura. Allusioni al pensiero taoista e alla tradizione cinese compaiono tanto nei suoi testi in prosa quanto nella sua vasta opera in versi a partire da Terredad (1978): le rane di una sua poesia gracidano meditabonde nel loro «taoismo solitario»,13 anche la cicala ha ormai appreso il segreto del Dao, e persino il bue è «quasi taoista».14 Nel Cuaderno de Blas Coll non solo troviamo riferimenti alla lingua cinese, considerata più efficace alla comunicazione del vero in virtù della sua semplicità monosillabica, ma anche un riferimento al Classico dei mutamenti (Yijing), uno dei testi fondamentali della tradizione dell’Asia Orientale.
Il taoismo è presente in Montejo profondamente, con la stessa naturalezza delle sue culture natali e pre-natali. Forse ci si è avvicinato leggendo i poeti cinesi dell’epoca Tang (618-907),15 anche se è arduo ricostruire il percorso della sua formazione “orientale”, perché non rimanda mai alle sue fonti, non cita i pensatori e i punti dottrinari che l’hanno ispirato. Quando dice “taoismo” sembra riferirsi a una tendenza dello spirito più che ad un corpus di precetti, a una generica forma mentis, che penetra nella sua poesia trasfigurata e spesso attraverso immagini archetipali, intorno alle quali, però, non si possono fare a meno di percepire chiaramente alcuni echi della riflessione di Zhuangzi,16 che rifletté, direi modernamente, sulla tendenza dell’uomo ad opporsi al flusso spontaneo e necessario delle cose.
Esplicitamente invece è presente nell’opera di Montejo il poeta cinese Li Bai (701-762), fra i maggiori dell’epoca Tang e senz’altro il più conosciuto in Occidente, amato a tal punto dal poeta della terredad da sceglierne l’opera come unica compagna letteraria nel viaggio alla ricerca dell’armonia: «In ogni nave mi aspetta una cabina, / un libro di Li Po17 per la traversata».18 Forse è proprio tra i suoi versi che Montejo ha scoperto «il cammino del Tao», perché Li Bai, abbandonando gli artifici della società per un’esistenza nei boschi incontaminati e riscoprendo una scrittura ispirata dal soffio costante della natura, seppe incarnare davvero l’ideale taoista della “spontaneità” (la reintegrazione dell’uomo alle correnti del cosmo).
In Montejo il pensiero della scuola del Dao è presente nella riflessione sul tempo, la morte e la Natura, nell’ascolto solenne dei canti terrestri. Lui stesso, nell’intervista raccolta da Marina Gasparini Lagrange, riconosce il carattere composito della propria concezione temporale, che lo fa dibattere tra l’idea di un tempo soggettivo e “lineare”, teso come freccia inarrestabile, e l’intuizione di un tempo “circolare”, che rinnova la vita senza tregua. Sa bene di essere figlio del meticciato culturale del Venezuela, il punto di incontro tra la raffigurazione cristiana e occidentale del tempo e dello spazio e quella amerindiana e africana, che racchiude la storia entro le spire dell’eterno ritorno, nella sfera, il cerchio o la spirale. Aggiungo, che sebbene mai lo espliciti, anche l’insegnamento taoista è essenziale alla definizione dei limiti temporali del suo mondo.
Per farci un’idea del modo montejiano di rappresentare il tempo è imprescindibile tener conto della sua nozione di spazio cosmico, per cui l’universo è come un fiume di materia in perpetua trasformazione, eterno e continuamente cangiante, in cui si esiste per un solo istante, come il lampo tra due forme, tra la materia e il nulla: come qualcosa di intermedio.
Una prospettiva prima di tutto eraclitea, ma anche taoista, perché tipicamente orientale è l’idea cosmologica di una costante trasformazione delle cose, che coinvolge inevitabilmente anche il concetto di tempo. Mentre nella nostra cultura esso rappresenta un’entità metafisica e inafferrabile nella cosmologia cinese esso è come il ritmo del mutamento, il movimento costante della materia: è la materia stessa, che vive, muore e si trasforma. Similmente ci appare nella poesia di Montejo, in cui si condensa al punto che le pietre immerse in un fiume lo percepiscono al tatto, come l'acqua.19
Leggendo la sua poesia si ha non soltanto l’impressione che siano abolite le frontiere del tempo, ma che la materia tutta coesista in un unico istante eterno, nella cui fissità il presente soggettivo e immediato esiste contemporaneamente ad ogni altro frammento di vita cosmica presente, passata e futura. Nel fluire universale nulla scompare nell’oblio o in qualche superrealtà, poiché nonostante la materia si trasformi incessantemente e le vite, i volti, le voci si succedano senza apparente soluzione di continuità, la loro sostanza resta immutata a sostenere il giro inarrestabile del cosmo. Così, nella massima concentrazione dei sensi, il poeta scopre che i corpi dei suoi antenati lo abitano, che lui è il paesaggio in cui sono sepolti:
[…] I miei antenati vanno e vengono lungo il mio corpo,
sono un’aria senz’aria che soffia dal lago,
un galoppo di ombre che scende
e si cancella in lontane piantagioni. […]20
La poesia per Montejo è anche un lungo viaggio nella materia del tempo, tra i cui flutti perdersi e girare come un ciottolo levigato, trasformato dalle onde: «Hai girato per il mondo più di ogni ciottolo; / hai perduto il nome, la tua città, / abbracciato a frammentarie visioni; / di tante ore: che ti resta?».21 Spesso il viaggio esistenziale è associato alla navigazione (v. Partenza, tr. it. di Alessio Brandolini), all’acqua nelle sue varie forme: l’acqua immobile e perfetta dei cristalli di neve, l’acqua senza fine dell’Atlantico reale o sognato, l’abisso notturno e assoluto del corpo («Il naufragio di un corpo in un altro corpo / quando nella sua notte, all’improvviso, cola a picco…»22), la pioggia verticale che separa la vita dalla morte,23 e infine l’acqua del fiume che scorre fuori e dentro ai corpi, che è in noi e ci trasporta («il fiume / che porto e mi riporta»24). Il poeta descrive una vera e propria geografia fluviale in cui si intrecciano i corsi dell’Orinoco che scorre verso il desiderio, del Tamigi, del Tejo, il vecchio fiume di Lisbona. Fiumi reali o immaginati, fiumi in cui ripercorrere la propria storia, ritrovare se stessi e la scaturigine della propria scrittura:
L’Orinoco attraversa la mia vita
una notte stellata ormai lontana.[…] L’Orinoco traccia un corso vasto
ma in quell’istante si unisce alla mia vita
presso il Delta.
Poi ognuno prosegue verso il mare,
baratta i sogni con il sale, se ne va sulle navi
che incrociano al capriccio delle onde.
25
A volte i fiumi sono metafora del tempo cosmico, dell’universo intero, e le loro acque simboleggiano quel fluido palpabile di materia, spazio e tempo in cui le nostre vite si percepiscono per un breve istante. Una delle più belle rappresentazioni del fiume “cosmico” è la poesia intitolata Io sono il mio fiume (Yo soy mi río, v. tr. it. di Alessio Brandolini).
Nella corrente l’io poeta si abbandona a un doppio movimento di ricezione-proiezione: accoglie in sé il lento ritmo dell’universo e al contempo si proietta sul suo immane fluire per tornare a sentirsi frammento assoluto che partecipa alla vita universale e in sé la ripete. Così proiettato sull’eterno fluire della materia esistente, può contemplare la sua vita momentanea come da un fiume si guarda il ponte che lo attraversa («vado attraversando il mio corpo come l’arcata di un ponte»26). Nella purezza delle acque, tra i flutti di tutto ciò che esiste, si dissipa l’io e la coscienza scivola in un vortice in cui si annodano presente, passato e futuro, in cui i cari morti nuotano nel corpo del poeta e parlano attraverso la sua voce, scaturiscono nella poesia.
Anche questo fiume in cui il poeta ritrova l’armonia tra il proprio corpo e la natura riecheggia il pensiero taoista. Non solo la letteratura occidentale, infatti, ha intessuto intorno all’acqua e ai fiumi un’intricata rete simbolica: metafore equoree e fluviali sono ricorrenti nell’immaginario taoista e soprattutto nell’opera di Zhuangzi, in cui il movimento spontaneo e inevitabile dell’universo spesso è simboleggiato dall’acqua che segue naturalmente il suo corso.
La portata “cosmica” del fiume montejiano ricorda da vicino proprio il concetto di Dao espresso nell’opera del Maestro Zhuang: ciò che «ha in sé la sua radice ed è sempre esistito, molto prima della creazione del cielo e della terra»,27 l’universo intero, la suprema armonia. Anche il taoista ricerca la “sintonia” tra l’io e l’universo e spesso l’esprime attraverso metafore legate al fluire dell’acqua, come quella del natante che si lascia andare alla deriva tra i flutti adeguandosi al corso di tutte le cose senza opporre resistenza:
Penetro con l’afflusso e riemergo col deflusso; seguo la Via dell’acqua senza imporle i miei bisogni individuali. Ecco come riesco a galleggiare in essa.
28
La stessa idea, la stessa serena accettazione dell’ordine delle cose, si ritrova alla base della poesia di Montejo, in cui ogni creatura eccetto l’uomo occupa in natura il posto che le è stato assegnato, solennemente dedita anche al più infimo lavoro, non per sacrificio, ma per la saggezza di chi sa, a dispetto della superbia umana, che lavorare per la vita è ufficio sacro e nessun ruolo è subalterno. Così, persino la formica che raccoglie le nostre amare briciole è una creatura divina («che sempre viaggia da remote stelle»29), mentre il samán se ne sta «dove i venti [lo] lasciarono / senza rinnegare i [suoi] dèi»30 e l’asino sopporta docilmente il suo lavoro, senza lamentarsi:
[...] Onore all’asino, al suo baule di farfalle,
dove custodisce i colpi di Dio e degli uomini
e non si lamenta mai.
31
Se per Montejo l’armonia ritrovata ha il nome di terredad, per il taoista essa è la “spontaneità” (ziran), l’inevitabile ordine delle cose; per entrambi è la legge della Natura perfetta, immutabile, eterna.
La tendenza a concepire il mondo naturale – ciò che è puro e primordiale, non antropizzato – in una prospettiva cosmica e trascendente è in Montejo innanzitutto un’inclinazione romantica connessa al motivo profondamente americano della dicotomia Natura-Cultura. Ma come non scorgere nei suoi paesaggi cangianti, nella “spontaneità” delle sue creature, nel suo perdersi nel fluire di tutte le cose un “che” di taoista? Un taoismo che certo non ambisce a porsi in continuità con la tradizione orientale, tantomeno a risultare coerente, ma questo poco importa alla poesia, in cui non vale il rigore filologico.
«La vida vale más que la vida»: la morte come trasformazione
Anche la riflessione intorno alla morte attinge a piene mani dalle letture taoiste. Sin dai primi libri (Élegos, 1967 e Muerte y memoria, 1972) la vita e la morte si intrecciano in un dialogo interminabile, ma, se in essi la fine si profila circondata da un’ombra tragica e irrimediabilmente legata al rimpianto per i cari scomparsi e i mondi perduti del passato, a partire da Terredad il dolore trascende la dimensione privata e domestica proiettandosi a un livello superiore della speculazione, in cui domina l’astratto dualismo tra il rimpianto per la perdita dell’individualità – la coscienza di sé, «questo miracolo di esser qui la vita»32 – e l’accettazione estatica del ciclo delle esistenze.
Nella contemplazione dei giri della materia cosmica si fa chiaro al poeta il moto circolare che soggiace all’esistenza, per cui tutto ciò che muore fa ritorno al «tempo terrestre» (Settembre, v. tr. it. di Alessio Brandolini) da cui rinasce sotto un’altra forma. Compresa la legge della metamorfosi, anche la morte gli si rivela come semplice fase dell’eterna trasformazione, come semplice cambiamento di stato. In questo è il suo taoismo, nella consapevolezza che la vicenda universale si sostiene sul giro provvisorio di ogni singola vita e che ogni morte è un nuovo inizio («non sono ateo di nulla / se non della morte»33).
Vi è ancora una sorprendente affinità tra la sua riflessione sulla morte e quella di Zhuangzi. Entrambi, stabilito che essa non è che un moto di rigenerazione, il passaggio a un’altra vita, a un’altra forma, trattano con ironia i rituali legati al lutto.
Montejo propone per la sua tomba un epitaffio «provvisorio» come la fine stessa e gioca a ipotizzare le sue future metamorfosi. Anche nell’opera di Zhuangzi si narrano con irriverenza gli aneddoti relativi alla morte: vi si legge di come il maestro abbia accettato con allegria la scomparsa della moglie festeggiando rumorosamente accanto alla sua salma, e di come abbia atteso la fine di un amico moribondo enumerandogli serenamente le forme possibili della sua trasformazione.
Montejo, però, non è un vero saggio taoista e la sua accettazione della morte resta parziale, momentanea, perché a differenza di Zhuangzi non è in grado di trascendersi in modo definitivo e approdare a una visione puramente oggettiva, distaccata della propria esistenza. La perdita dell’unicità nella morte, che il taoista concepisce come un fatto necessario, “spontaneo”, non può che risuonare inquietante a un poeta che dal principio della sua attività creativa fissa romanticamente il centro dell’universo nell’io e nella dimensione domestica. Tra i suoi versi, quindi, accanto all’accettazione lirica della morte, spesso si profila il senso tragico della perdita dell’io e della stagione straordinaria trascorsa sulla terra, dando vita a quella che è forse la vera tensione irrisolvibile della sua poetica.
Che parli la vita: è questo lo scopo, la terra?
Un così grande miracolo finisce senza miracolo?
Questo stupore vissuto ora dopo ora
che ci giunge da un albero, da un volto
questo conteggio di Dio termina in uno zero? […]
34
Il canto della natura
Terredad e taoismo confluiscono infine nella tematica del canto della natura, che coinvolge anche la riflessione sulla funzione del poeta e sul linguaggio umano e si dispiega lungo tutto l’arco dell’opera montejiana, approdando alla più nitida e completa definizione nel poemetto intitolato Partitura de la cigarra (1999).
Alla fitta rete delle corrispondenze cosmiche, alla solidarietà naturale, alla legge circolare che soggiace alla materia, corrisponde un coro eterno che esplode nelle innumerevoli voci terrestri. Un canto palpabile, un dialogo “tattile” fra le creature, che non ha bisogno di parole o di suoni per trasmettersi, perché in esso il pensiero e la voce si fanno densi e carichi di materia, stringendo animali (passeri, cicale, tordi, rane), alberi e minerali (le pietre porose che parlano al bue) in un magma sonoro. Questo «suono solido»35 è la forza musicale che fa girare il mondo,36 il sussurro degli dèi profondi della materia che pervade i corpi e scaturisce in canto, trasformando le creature della terredad in veri e propri “strumenti divini”, cantori e portatori di un messaggio rivelatore.
Anche quest’immagine è profondamente taoista, perché il taoismo spesso rappresenta l’armonia cosmica con l’immagine di una musica divina che sprigiona da tutto ciò che esiste, metafora del qi, il soffio trascendente, il principio che infonde la vita e, come la musica montejiana, sopravvive ai corpi perituri delle creature cantanti.
[…] si ode sempre una cicala e un’altra cosa,
qualcosa che supera il suo canto e lo riecheggia,
qualcosa che non muore con lei ma l’accompagna,
qualcosa che ha bisogno della cicala per ascoltarsi,
l’altra metà del suo silenzio che dura tanto,
l’altro frammento d’ombra che le serba il sole… […]
37
Canto come soffio, dunque, come verbo creatore, scaturigine della vita, messaggio assoluto, che pervade la cicala e le altre creature innocenti rendendole sagge, interpreti consapevoli della partitura universale:
[…] cicala mistica nel più verde dei templi,
cicala che conosce il cammino del Tao,
il cammino del silenzio che canta […]
38
Il poeta vorrebbe decifrare e tradurre quel canto, ma non può farlo poiché dimentico della fonetica primordiale e prigioniero di un linguaggio astratto e rigidamente autoreferenziale. Per questo, intuendo che nella voce del tordo nero parla un albero, ammette di non saper che fare con quel grido, di non saperlo «annotare».39
Attraverso l’immagine di un Orfeo «balbuziente», smarrito nella città infernale tra parole elettroniche, registrate, incapaci di «intenerire» la pietra e le creature innocenti, Montejo comunica il dolore lacerante del poeta contemporaneo che non sa più parlare agli alberi e agli uccelli come il cantore mitologico, perché la sua parola, astratto, vuoto contenitore, pura denotazione, non incarna una vita e il suo significato trascendente, non penetra come un fluido nella mente altrui imprimendovi l’idea perfetta.
Eppure, nonostante l’intorpidimento della parola umana, incapace di tradurre il mondo come il canto di un passero o di una cicala, Montejo rimane fedele alla scrittura e, come un alchimista, cerca di sublimare la parola quotidiana, di «trasmutare […] in oro il fango umano»,40 attraverso l’ascolto del canto naturale: «Alle onde di questa riviera devo profonde lezioni di eufonia, di intonazione sillabica, che nessuno dei nostri accademici si è mai sognato in tutta la vita».41 Grazie a tanta dedizione la poesia recupera, almeno parzialmente, il valore sacro e operativo che aveva al tempo dell’Orfeo mitologico, risultando addirittura l’unico legame dell’uomo contemporaneo col trascendente, «l’unica religione che ci rimane».42
La valenza sacra del verso e della parola poetica si deve tanto all’opera faticosa di affinamento del ritmo verbale e di ricerca di un suono più “terrestre” – dunque ad uno sforzo cosciente del poeta – quanto ad un meccanismo assolutamente involontario dello spirito, che soprattutto di notte – perché Montejo è un poeta notturno – si riempie goccia a goccia del canto universale, facendo del poeta un altro “strumento divino”, come il gallo di una poesia:
[…] Il canto sta riempiendo, incontenibile,
il gallo come fosse un’anfora;
riempie le sue piume, la sua cresta, suoi speroni,
fino a straripare e si ode immenso il grido
che attraverso il mondo si sparge senza tregua. [...]
43
La sacralità della poesia dipende dunque dalla sua origine, che non risiede nella coscienza, ma in un canto, un’energia, un senso ulteriore che pervade il corpo e la mente del poeta umano fino a traboccare nella scrittura, nella parola poetica. Lo stesso Montejo ci fa notare che si tratta di un concetto di ispirazione molto diverso rispetto a quello che ha dominato la letteratura occidentale sin dai tempi dei greci, più vicino senz’altro all’interpretazione orientale dell’ideazione poetica:
Bisogna ricordare […] che per gli orientali, per i poeti cinesi e giapponesi, ad esempio, l’antico concetto di ispirazione, così come noi lo conosciamo fino dai tempi dei greci, risulta loro estraneo. Tutta la fonte della poesia, secondo loro, sta nella fusione totale dell’uomo, del poeta, con la natura.
44
Per quanto riguarda la poesia cinese, allude indubbiamente ad un modo di poetare sorto entro un circolo di poeti e artisti passati alla storia come “i Sette Saggi del bosco di bambù” (Zhulin qixian), che nel III secolo si riunivano all’esterno delle mura della città di Luoyang e, immersi nella semplicità della natura, spesso sotto l’ebbrezza dell’alcol, si dedicavano alla composizione in versi, riaccordando la mente alla spontaneità del Dao. Il poeta Li Bai, compagno ideale delle navigazioni montejiane, è considerato l’erede dei Sette Saggi, poiché anch’egli nell’atto creativo si lasciava interamente possedere dall’armonia naturale.
Anche Montejo, quando scrive, abbandona per brevi istanti i freni della ragione e si lascia guidare la mano da una forza esteriore alla coscienza, che lo possiede ed esplode in ritmo verbale:
Essere lo schiavo che ha perduto il suo corpo
così che le parole possano abitarlo.
Al posto delle ossa avere flauti innocenti
che qualcuno suona da lontano
o forse nessuno. (È reale solamente il soffio
e l’ansietà per decifrarlo) […]
45
In quei momenti di sfrenata incoscienza lo spiritus mundi soffia attraverso il suo corpo come in un flauto d’osso, concentrandosi in densa energia che stimola il canto. Come il qi, direbbe un taoista, come la forza divina, ulteriore, ineffabile, che forma tutto ciò che esiste: lo spirito, il corpo, la terra, la poesia che perciò è vita, territudine, «parola della terra».
1Tr. it. di Claudia Ianniciello. Versione originale: «Toda frase debe reproducir en su construcción, tanto como sea posible, la forma de gravitación de los astros. El sujeto debe rotar como el sol» (El Cuaderno de Blas Coll, Universidad de Antioquia, 2005, p. 44).
2Tr. it. di Alessio Brandolini. Tutte le traduzioni di Alessio Brandolini sono riportate integralmente nella scelta di poesie proposta alla fine di questo articolo.
3Preghiera tattile, tr. it. di Claudia Ianniciello. Versione originale: «Toco la tierra con mis manos, / esta tierra sagrada y tan antigua / adonde mis padres me trajeron [...] Soy el que va soñando entre las cosas, / la lumbre que se encarna de este sueño / y tierra viva, palabra de la tierra, / un ínfimo fragmento de su espejo, / jamás en el espacio nos hemos separado» (Eugenio Montejo, Oración por el tacto, in Adiós al siglo XX, bid & co., 2004, p. 24).
4Territudine, tr. it. di Alessio Brandolini.
5Sentire, tr. it. di Martha L. Canfield, in Eugenio Montejo, La lenta luce del tropico, Firenze, Le Lettere, 2006, p. 11). Versione originale: «Sentir. La tierra gira porque siente / el espacio estrellado. Y el mar y el mundo / y el minúsculo tallo de la hierba».
6Gli alberi, tr. it. di Luca Rosi, in ivi, p. 27. Versione originale: «Hoy, por ejemplo, al escuchar el grito / de un tordo negro, ya en camino a casa, / grito final de quien no aguarda otro verano, / comprendí que en su voz hablaba un árbol, / uno de tantos».
7Settembre, tr. it. di Alessio Brandolini.
8Credo nella vita, tr. it. di Alessio Brandolini.
9Francisco Rivera, La poesía de Eugenio Montejo, in Entre el silencio y la palabra, Caracas, Monte Ávila, 1986, p. 43.
10Settembre, tr. it. di Alessio Brandolini.
11Colori, tr. it. di Alessio Brandolini.
12Tr. it. di Claudia Ianniciello. Versione originale: «el mismo que el del planeta que nos lleva y, en general, que el de la galaxia de la cual somos una minúscula partícula. Procede invariablemente, como las agujas del reloj, de izquierda a derecha; es pues dextrorso. [...] mientras no alcancemos las asimetrías de estas espirales inversas que yacen ocultas en nosotros, no sacaremos a la luz ciertas ideas cuya enigmática belleza ha de parecernos tan sorprendente como el mítico cuaderno de un narval» (Eugenio Montejo, El Cuaderno de Blas Coll, cit., pp. 72-73).
13Eugenio Montejo, Las ranas, in Alfabeto del mundo, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 220.
14Eugenio Montejo, El buey, in ivi, p. 208.
15L’epoca Tang è il periodo d’oro della poesia cinese e in cui le arti in generale vivono uno straordinario rinascimento. Oltre che da un fervore letterario la Cina è caratterizzata in questi anni da una straordinaria vivacità spirituale, che favorisce la diffusione di due dottrine tradizionalmente invise alla casta dei letterati confuciani: taoismo e buddhismo.
16Zhuang Zhou (o Zhuangzi, lett. Maestro Zhuang) è tradizionalmente considerato uno dei “Padri del taoismo”. Visse nel III secolo a.C. ed elaborò la propria dottrina in un corpus di scritti eterogenei, ai quali si sommano il materiale della sua scuola, documenti di autori vari e aggiunte dei compilatori, rifluiti tutti nel Zhuangzi, l’opera del Maestro Zhuang.
17Montejo riporta la trascrizione del nome cinese più diffusa in Occidente, quella che utilizza il sistema Wade-Giles. Io invece ho utilizzato quella in pin-yin, il sistema di trascrizione fonetica più recente.
18Partenza, tr. it. di Alessio Brandolini.
19Cfr. Le pietre, tr. di Alessio Brandolini.
20I miei antenati, tr. it. di Luca Rosi, in Eugenio Montejo, La lenta luce del tropico, cit., p. 55. Versione originale: «Mis mayores van y vienen por mi cuerpo, / son un aire sin aire que sopla del lago, / un galope de sombras que desciende / y se borra en lejanas sementeras».
21Torna ai tuoi dèi profondi, tr. it. di Alessio Brandolini.
22Il naufragio, tr. it. di Luca Rosi, tratta da Eugenio Montejo, La lenta luce del tropico, cit., p. 118. Versione originale: «El naufragio de un cuerpo en otro cuerpo / cuando en su noche, de pronto, se va a pique…».
23Cfr. Eugenio Montejo, Otra lluvia, in Muerte y memoria, Universidad de Carabobo, 1972.
24Una città, tr. it. di Alessio Brandolini.
25L’Orinoco, tr. it. di Claudia Ianniciello. Versione originale: «El Orinoco pasa por mi vida / en una noche de astros ya muy lejos. [...] El Orinoco traza un curso vasto / pero se une a mi vida en ese instante / cerca del Delta. / Después cada uno prosigue hacia la mar, / cambia sueño por sal, se ausenta en los navíos / que cruzan al azar de la corriente» (Eugenio Montejo, El Orinoco, in Algunas palabras, Caracas, Monte Ávila, 1976, p. 55).
26Io sono il mio fiume, tr. it. di Alessio Brandolini.
27Zhuangzi, Zhuangzi, cap. VI, a cura di Liou Kia-Hwai, Milano, Adelphi, 1992, p. 61.
28Zhuangzi, Zhuangzi, cap. XIX, in Angus C. Graham, La ricerca del Tao. Il dibattito filosofico nella Cina classica, a cura di Riccardo Fracasso, Vicenza, Neri Pozza, 1999, p. 253.
29Territudine, tr. it. di Alessio Brandolini.
30Un Saman, tr. it. di Alessio Brandolini.
31Onore all’asino, tr. it di Claudia Ianniciello. Versione originale: «Honor al asno, a su baúl de mariposas, / donde guarda los golpes de Dios y de los hombres / y no se queja nunca» (Eugenio Montejo, Honor al asno, in Adiós al siglo XX, cit., p. 27).
32Eugenio Montejo, Milagro puro, in Papiros amorosos, Valencia, Pre-Textos, 2002, p. 37.
33Credo nella vita, tr. it. di Alessio Brandolini.
34Finale, tr. it. di Alessio Brandolini.
35Eugenio Montejo, Partitura de la cigarra, XIII, in Partitura de la cigarra, Valencia, Pre-Textos, 1999, p. 65.
36Cfr. Uccelli, tr. it. di Alessio Brandolini.
37Eugenio Montejo, Partitura della cicala, V, in ivi, p. 53. Tr. it. di Claudia Ianniciello. Versione originale: «se oye siempre una cigarra y otra cosa, / algo que no cabe en su canto per lo menciona, / algo que no muere con ella pero la acompaña, / algo que precisa de la cigarra para escucharse, / la otra mitad de su silencio que dura tanto, / el otro pedazo de sombra que el sol le guarda... ».
38Ibidem. Versione Originale: «cigarra mística en el templo más verde, / cigarra que conoce el camino del Tao, / el camino del silencio que canta».
39Cfr. Eugenio Montejo, Los árboles, in Algunas palabras, cit., p. 7.
40Lo schiavo, tr. it. di Alessio Brandolini.
41Tr. it. di Claudia Ianniciello (Eugenio Montejo, El Cuaderno de Blas Coll, cit., p. 44). Versione originale: «A las olas de esta ribera debo profundas enseñanzas de eufonía, de entonación silábica, que ninguno de nuestros académicos ha soñado en toda su vida».
42Marina Gasparini Lagrange, Intervista all’autore, in Eugenio Montejo, La lenta luce del tropico, cit., p. 142.
43Il canto del gallo, tr. it. di Luca Rosi, in ivi, p. 69. Versione originale: «El canto está llenando, incontenibile, / al gallo como un cántaro; / llena sus plumas, su cresta, sus espuelas, / hasta que lo desborda y suena inmenso el grito / que a lo largo del mundo sin tregua se derrama».
44Marina Gasparini Lagrange, Intervista all’autore, op. cit., p. 138.
45Lo schiavo, tr. it di Alessio Brandolini.
TERRITUDINE
poesie di Eugenio Montejo
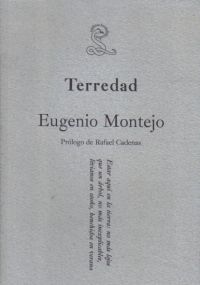
Le poesie proposte sono tratte da Terredad (Caracas, Monte Ávila, 1978) e tradotte Alessio Brandolini, curatore della prima edizione italiana del libro in uscita presso la casa editrice Raffaelli di Rimini.
|